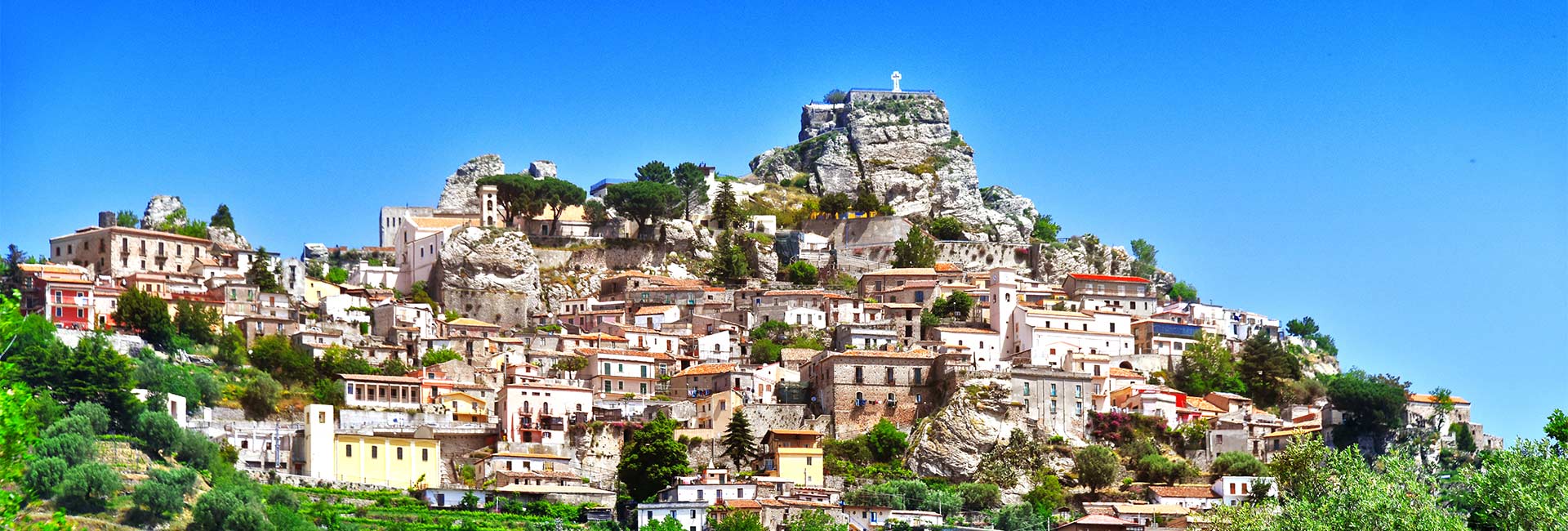«Suso in Italia bella giace un laco….c’ha nome Benaco». Nel Canto XX dell’Inferno, Dante fa cenno al Lago di Garda, che all’epoca si chiamava ancora Benaco. Per descriverlo, si potrebbero forse usare le stesse parole che avrebbe usato l’Alighieri allora, perché il contesto naturalistico non è poi così cambiato. Il Monte Baldo che lo separa dal Trentino è sempre lì, a dominare il bacino più grande del Paese e offrendo il suo fianco al Parco Naturale Locale Monte Baldo, creato a tutela di quello che è stato ribattezzato Hortus Italiae per la ricca biodiversità. Caratteristica che dal ‘400 in poi ha fatto da richiamo per studiosi, farmacisti e speziali, fra cui tale Francesco Calzolari che la celebrava con queste parole: “tanta varietà di pianta quanta in nessuna altra parte d’Italia”.
Ma il Baldo è solo un tassello di quel microcosmo rappresentato dal Garda, climaticamente, culturalmente e storicamente. Basti pensare a Sirmione, con le Grotte di Catullo a ricordare che questa era già meta di vacanza per gli Antichi Romani. Da lì, facendo il periplo dei 158 km di costa, si può partire alla scoperta di borghi e cittadine che nei secoli hanno ospitato personalità di ogni genere, fra cui molti artisti e scrittori incantati da un paesaggio sempre ricco di sorprese. Un periplo che tocca Lombardia, Veneto e Trentino, offrendo un melange di tradizioni assai diverse fra loro che si interfacciano e contaminano, anche grazie alla sua geolocalizzazione che lo pone esattamente al centro dell’Europa.
Anche per questo, il Garda è ogni anno meta di milioni di turisti del nord e centro Europa, che qui trovano soddisfazione in luoghi ricchi d’arte, bellezza e buona tavola, una sintesi perfetta del Bel Paese, con il plus di un clima mite tutto l’anno ideale per praticare sport di ogni genere: trekking, MTB, sci e, grazie al vento tipico del mezzogiorno, l’òra, vela, windsurf e kite.