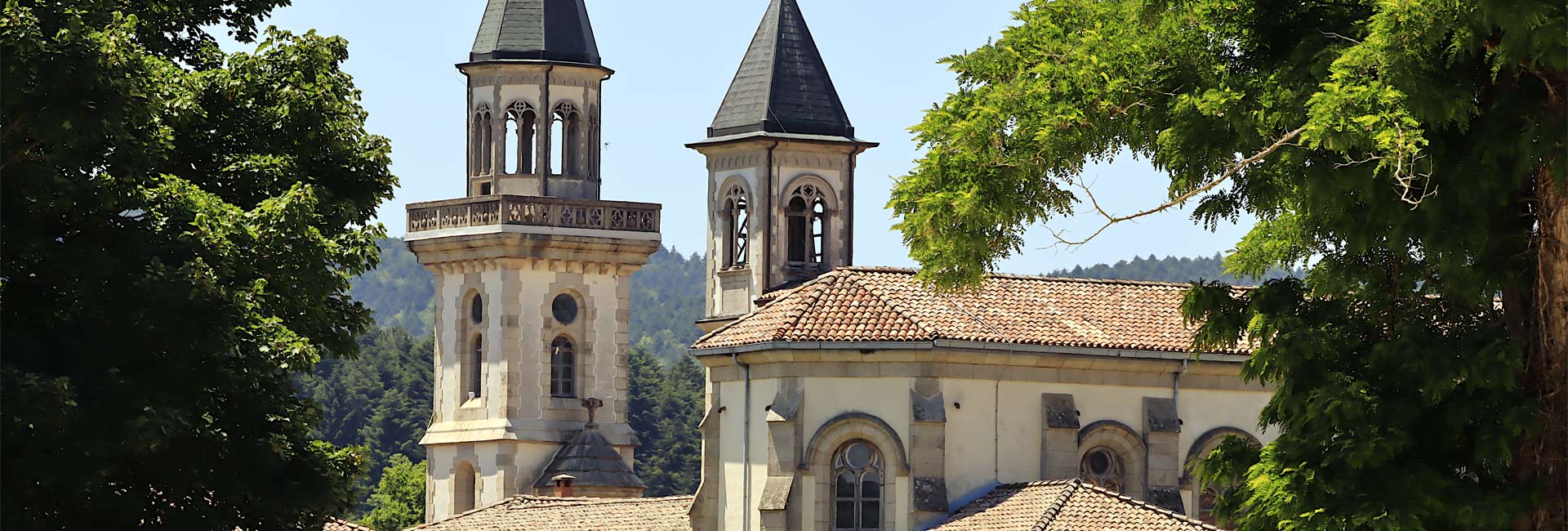I nomi che identificano i principali piatti o prodotti calabresi suonano spesso criptici ai forestieri, celando tradizioni antiche e poliglotte. Greci, Romani, Normanni e Arabi oltre che nell’architettura hanno lasciato il segno anche a tavola, soprattutto nella cucina delle piane più prossime al mare. Richiama la francese andouille la ‘Nduja, salsiccia di carne, lardo, fegato e polmone di maiale, originaria di Spilinga e dei comuni limitrofi dell’altopiano del Monte Poro, area nota anche per la produzione di un Pecorino, detto appunto di Monte Poro o “casu”, ottimo al naturale o alla griglia o come condimento di piatti filanti. La devozione locale per il suino è testimoniata anche dalla Sopressata Dop e da un piatto tradizionale come il murseddo, striscioline di trippe, fegato di vitello e maiale con l’aggiunta di pomodoro e peperoncino, racchiuse nella pitta, disco di pasta di pane che richiama la greca pita. Carne di porco pure nelle opulente sagne chine, lasagne imbottite con macinato di maiale, piselli, cacio, funghi, carciofi e uova sode. Altrettanto iconica come la ‘Nduja è la Cipolla rossa di Tropea IGP, vessillo della zona di Vibo Valentia. Particolarmente utilizzata per la preparazione di insalate fresche, è impiegata anche come ingrediente base di specialità gastronomiche tra le più varie, quali conserve, condimenti, salse, paté e confetture, e persino un gelato a dir poco sui generis. Il dolce calabro per eccellenza è originario della stessa provincia: è il Tartufo di Pizzo, nato qui in virtù dell’usanza di utilizzare la neve delle Serre e della Sila per realizzare granite e sorbetti con le fragole di bosco locali, o con le mandorle e i limoni della vicina Sicilia.
Il borgo di Buonvicino, nel cosentino, è invece legato a un altro agrume, il cedro, mentre il Bergamotto di Reggio Calabria è una DOP che dà i suoi frutti anche con l’olio essenziale, utilizzato nella cosmetica e nella profumeria di lusso.
Quanto ai vini, rapidi passi da gigante sono stati fatti negli ultimi anni in fatto di qualità, permettendo alle aziende locali di arrivare alla classificazione di ben 8 Doc e 6 IGP. A fare da portabandiera dell’Enotria, “terra del vino” – così l’avevano ribattezzata i coloni greci – è oggi il Cirò Doc, prodotto a Cirò e Cirò Marina, nel crotonese, come rosso, rosato e bianco. Nella stessa provincia si coltivano altre due Doc, il Santa Anna di Isola di Capo Rizzuto e il Melissa, con blend di uve che comprendono Gaglioppo, Nocera, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco.
Si va in provincia di Cosenza per degustare invece i Doc Savuto e Terre di Cosenza, dove sono state identificate sette sottozone, caratterizzate dalla produzione di vini particolarmente pregiati, quali Condoleo, Donnici, Esaro, Pollino, San Vito di Luzzi, Colline del Crati e Verbicaro. Nel catanzarese si beve invece con lo Scavigna Doc, bianco e rosso. Se la zona è quella di Reggio, si pasteggia con Bivongi e Greco di Bianco Doc. Gli IGP riportano invece i nomi di borghi come Scilla e Palizzi, di zone quali Locride, Costa Viola e Val di Neto e persino di un fiume, il Lipuda, IGP che nel suo Dna comprende un blend di Aglianico, Ansonica, Cabernet Franc, Greco Bianco e altri vitigni autoctoni e non.