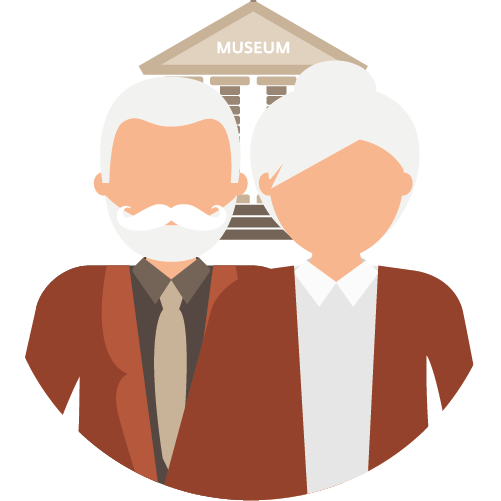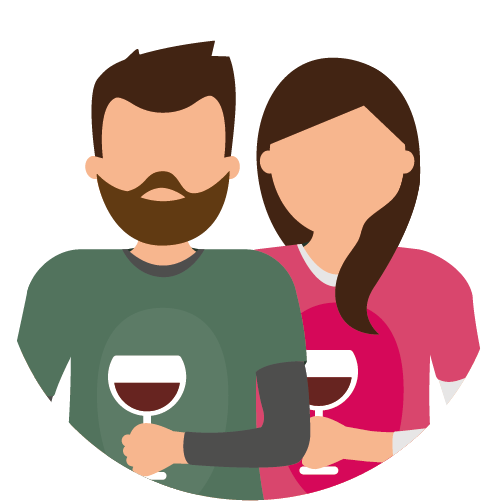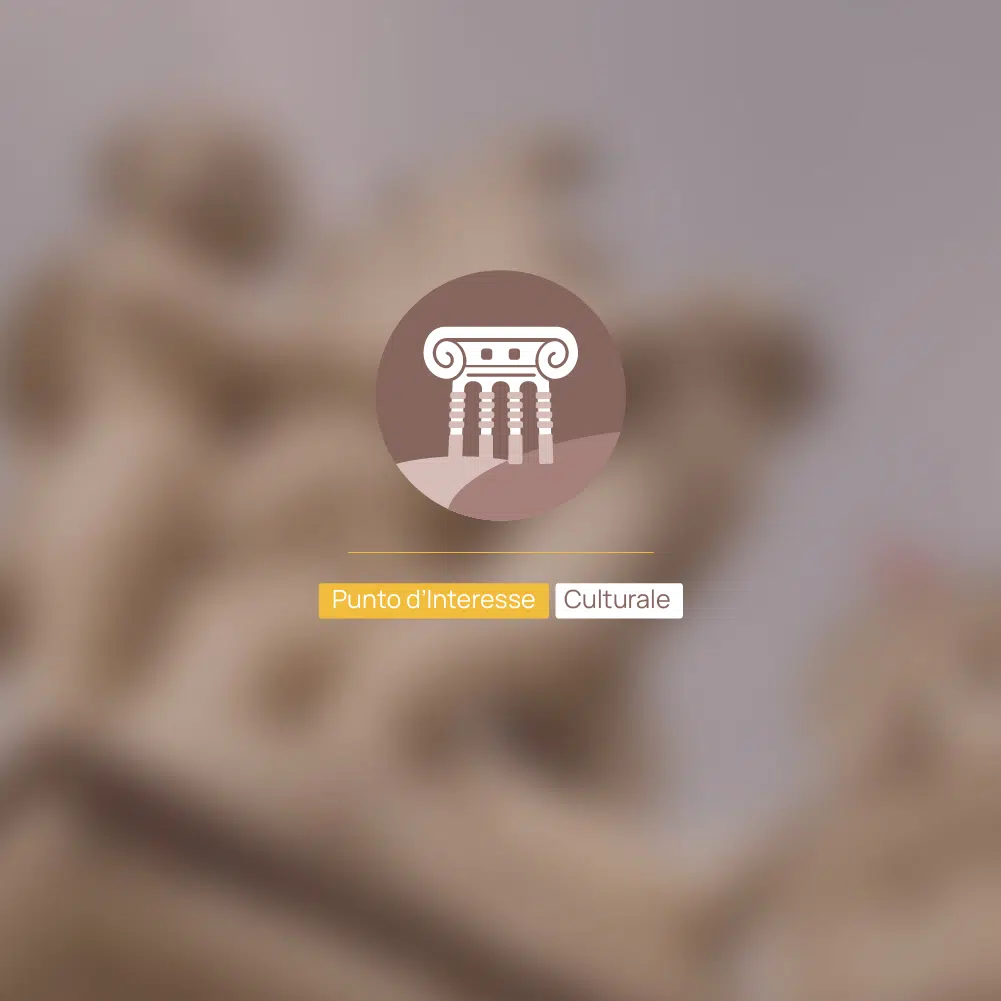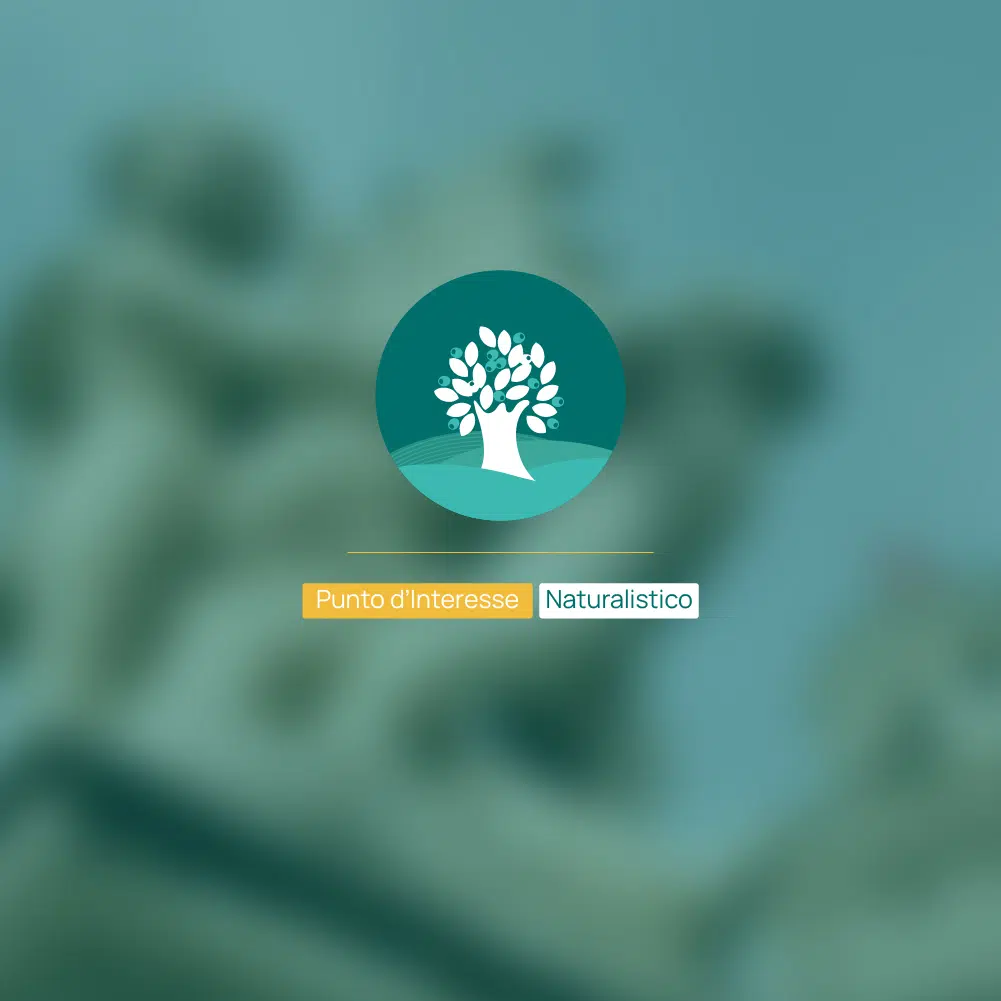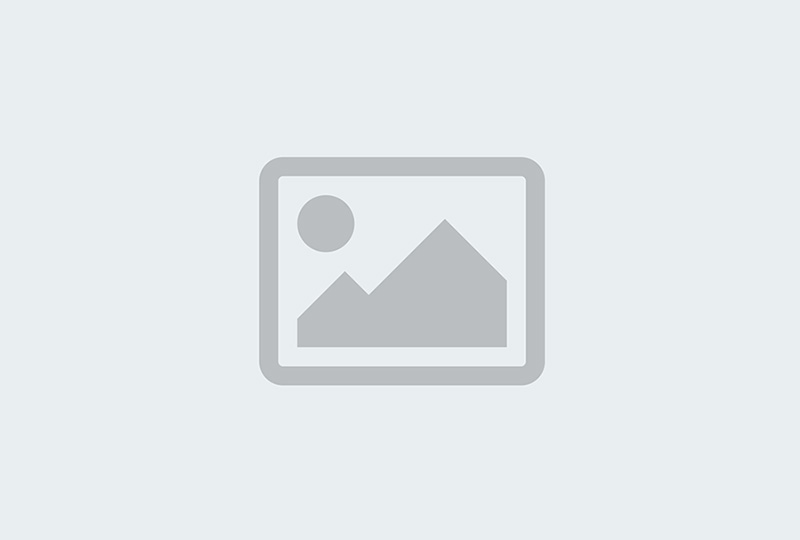Con la sovrapposizione di tredici dominazioni nell’arco di duemila anni, la Sicilia è oggi un puzzle di culture e tradizioni in grado di riassumere secoli di storia e civiltà fiorite nel bacino mediterraneo, di cui è pure l‘isola più grande. Grazie ai suoi quasi 26.000 km2 di superficie, è poi la Regione più estesa d’Italia, la settima isola d’Europa e, curiosità, la 45esima al mondo, comprendendo anche alcuni arcipelaghi, come quelli delle Eolie, delle Egadi, delle Pelagie, dello Stagnone e dei Ciclopi, oltre alle romite Ustica e Pantelleria.
Una varietas multiculturale enfatizzata da quella altrettanto generosa a livello geografico, offrendo un territorio vasto e suddiviso in nove province, ciascuna con la propria identità, ma dal 1946 assemblate in un’unica Regione a Statuto Speciale, e prima ancora, dal 1130 al 1816, nel Regno di Sicilia, annessa infine nel 1860 per plebiscito a quello d’Italia. Non è dunque un caso che, grazie a questo suo “identikit”, i sette siti siculi inseriti nel listing ufficiale del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco comprendano sia luoghi d’arte che realtà naturalistiche: fra i primi, la Val di Noto con i suoi centri Barocchi, vale a dire Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Caltagirone, Scicli e Militello; Siracusa e la Necropoli Rupestre di Pantalica in quanto una delle più grandi e meglio conservate di epoca preistorica; la Valle dei Templi di Agrigento; la Villa del Casale a Piazza Armerina, vicino Catania, grazie alla magnificenza dei mosaici e dell’architettura dell’edificio patrizio di epoca romana; la Palermo Arabo-Normanna, comprendente 9 beni tutelati, fra cui il celebre Duomo di Monreale e quello di Cefalù. Fra i siti Unesco naturalistici troviamo invece le Isole Eolie, dal fascino tipico di una terra di origini vulcaniche, e il Monte Etna, cuore dell’omonimo Parco, uno dei cinque regionali, insieme a quelli dei Monti Sicani, dei Nebrodi, delle Madonie e a quello fluviale dell’Alcantara. Unico Parco Nazionale è quello dell’Isola di Pantelleria, in virtù delle rare specie endemiche di flora e fauna, mentre infinite sono le riserve naturali, le aree marine e le zone umide protette, per un totale di 10,5% di territorio posto a vario titolo sotto tutela. Basti citare ad esempio la Riserva naturale integrale Grotta Conza, del Fiume Ciane e Saline di Siracusa, l’Oasi del Simeto, quella Orientata Bosco di Santo Pietro, di Cavagrande del Cassibile, l’Oasi Faunistica di Vendicari e quella dei Pini di Aleppo. Fra le Aree marine protette, altrettanto numerose, Capo Gallo – Isole delle Femmine, quella di Torre Salsa e quella dell’Isola dei Ciclopi di fronte ad Aci Trezza, che già nel nome riecheggia miti e leggende qui mai sopite.
Proprio partendo da uno di questi punti di interesse così speciali si può cogliere una sorta di metafora della storia della Sicilia stessa: se è vero che la Necropoli di Pantalica è stato un tempo luogo di morte, lo era ed è in senso cristiano anche di resurrezione, un po’ come ci raccontano gli annali locali, in un continuum di distruzioni e rinascite, conseguenti a guerre, invasioni, eruzioni e terremoti che hanno caratterizzato ogni epoca, passata o vicina. Memorabile, per gli effetti catastrofici che causò soprattutto nella Sicilia Orientale, fu quello del 1693, da cui però si ebbe una ri-genesi artistica e architettonica che ha appunto portato a quel crogiuolo di tesori inestimabili che è oggi la Valle di Noto. Esuberante, esagerato, esibizionista, unico. Così hanno voluto il Barocco gli aristocratici di Scicli e Modica, nel ragusano, risalendo la costa est fino alle pendici dell’Etna, plasmando infine il centro storico di Catania. Simile ma allo stesso tempo diverso nello spirito è il Barocco di Palermo, lustro e vanto delle casate più “gattopardesche”, accostato a quel mix di stili che vedono una copiosa alternanza di epoche e culture, che va dalla reggia islamica della Zisa all’eleganza Liberty di Via Ruggiero Settimo.
Specchio di tanta opulenza di contenuti è anche la cucina, che varia a seconda della zona: se a est prevale una tavola semplice, nell’entroterra vince una versione ancora più schietta, mentre a ovest si fanno ancora sentire l’influsso arabo e i fasti di corte. Comune e diffuso ovunque è il concetto del piatto unico a base di pasta, condita con pesce o carne, oppure con le verdure, come l’intramontabile pasta alla Norma, originaria di Catania, o il trapanese cuscus, versione ittica di quello arabo. Il trionfo dei sapori lo si raggiunge poi al momento del dessert, idealmente un buffet infinito di dolcezza portata fino quasi all’eccesso, in una vera festa di colori, in cui pasta martorana e cassata spiccano su tutto. Superbi anche i vini, che affondano le radici nei secoli ma solo di recente hanno riscosso il meritato successo. Ipercromatiche, chiassose e sempre cariche di storia sono anche le feste tradizionali che animano la scena in ogni stagione dell’anno: il Festino di Santa Rosalia a Palermo e Sant’Agata a Catania sono le due patrone più celebri e celebrate, il Carnevale si traduce nell’Abballu di li Diavuli, mentre con il teatro dei Pupi si apprezza la rappresentazione della vita, a tratti grottesca ma straordinariamente ricca di suggestioni storiche.
Cerca per
37 elementi Cosa fare e vedere
Parco Archeologico di Segesta
Calatafimi-segesta, Sicilia
Seduti sui gradini del teatro antico di Segesta, lo sguardo si perde in una verde vallata che digrada dolcemente verso il mare. Per chi c’è stato, nulla da invidiare al teatro di Epidauro, nel Peloponneso, e nemmeno a quello di Siracusa, dall’altra parte della Sicilia. Siamo in provincia di Trapani, di cui il Parco Archeologico di Segesta è una delle principali attrazioni. Mancarne la visita sarebbe un peccato, perché aggirarsi fra i resti dell’antica città degli Elimi, popolo di cultura e tradizione peninsulare originario di Troia, regala una sensazione di pace e lascia ricordi di bellezza senza tempo. Splendido, oltre al teatro che ogni estate fa da sfondo a un Festival dedicato a tutte le forme d’arte, dalla danza alla musica, dalla recitazione alla poesia, anche il tempio in stile dorico perfettamente conservato, che fa immaginare il potere di questa antica colonia che nel 307 a.C. fu distrutta da Agatocle di Siracusa, il quale la ribattezzò Diceòpoli, “città della giustizia”, per poi rinascere sotto il dominio dei Romani. Quest’ultimi infatti, grazie alla leggendaria comune origine troiana, la esentarono da tributi, le diedero in gestione un vasto territorio e le permisero una nuova fase di prosperità. Non solo, tra il II e I secolo a.C., Segesta venne totalmente riprogettata, assumendo un aspetto fortemente scenografico, subendo poi gli influssi della cultura musulmana e infine normanno-svevo.
La Cascata delle Due Rocche
Corleone, Sicilia
Fra gennaio e aprile e nei mesi autunnali, la Cascata delle due Rocche di Corleone dà il meglio di sé. L’acqua del fiume San Leonardo, affluente del Belice, scorre copiosa e trasforma quei 4 metri di balzo in un’attrazione nota anche al di fuori della provincia di Palermo. Il contesto è da set cinematografico: il laghetto che si forma ai piedi della cascata assume sfumature verdastre, la roccia tutt’attorno ha colori e conformazione da canyon del Far West, e una volta attraversata la fitta vegetazione, si arriva dinanzi al Convento del SS Salvatore. L’escursione è di quelle che soddisfano sia chi è in cerca di un contatto con la natura, sia degli appassionati di arte e architettura, in quanto il Parco Naturale della Cascata delle due Rocche è inserito nella più vasta Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, Rossa Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, che al suo interno custodisce anche la splendida Casina Reale di Caccia voluta da Ferdinando I delle Due Sicilie, capolavoro architettonico del primo Ottocento.
Borgo della Cunziria
Vizzini, Sicilia
In Sicilia non mancano certo i siti archeologici, ma vicino Vizzini, in provincia di Catania, ce n’è uno speciale, di archeologia industriale dell’Ottocento. Si tratta della Cunziria, un vero unicum, formato da un piccolo borgo costituito da 40 case-bottega, alcune a più piani, con la chiesetta dedicata a Sant’Eligio come cuore del paese. Il nome dialettale suggerisce l’antico mestiere che qui veniva praticato fino a un secolo fa: la concia delle pelli, un’attività per secoli fiorente ma abbandonata con il sopraggiungere dell’industrializzazione. Cristallizzato in un’epoca che non c’è più, la Cunziria conserva il suo fascino, lasciando immaginare la vita che qui si faceva un tempo, dietro quelle mura incrostate, nelle piazzette e nelle stradine dove fichi d’India e piante di sommacco creano un labirinto in cui è bello perdersi. Una realtà che ricorda quasi un set cinematografico, ma anche un po’ i racconti di Giovanni Verga, e non è un caso. Lo scrittore era nativo proprio di Vizzini, dove ambientò parecchie novelle, e qui furono girate alcune scene de la “Cavalleria Rusticana” e “La Lupa”.
Necropoli di Realmese
Calascibetta, Sicilia
Con 288 tombe a grotticella, la Necropoli di Realmese è di tipo Pantalicano, simile cioè alla celebre necropoli di Pantalica, in provincia di Siracusa. Qui siamo invece a 3 km da Calascibetta, nell’ennano, nel cuore della Sicilia centrale. Due le epoche di origine: le prime tombe risalgono all’età protostorica, cioè al IX secolo a.C., mentre le altre sono di età arcaica, del VI secolo a.C., in parte frutto di un riutilizzo delle precedenti fasi “costruttive”.
A riportare alla luce la necropoli di Realmese sono state una serie di campagne di scavo, la prima delle quali risalente agli anni 1949-1950. Condotta dall’archeologo Luigi Bernabò Brea, fece emergere numerosi reperti, fra ceramiche, coltellini, anelli, orecchini e fibule, utili per la datazione del sito archeologico. Monili e oggetti sono oggi esposti presso il Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa.
Cattedrale di Nicosia
Nicosia, Sicilia
Oggi si trova in provincia di Enna, ma quando nel 1388 la Cattedrale di Nicosia, dedicata a San Nicola di Bari, fu ufficialmente riconosciuta come parrocchia, apparteneva all’arcidiocesi di Messina. Le sue origini risalgono a circa un secolo prima, agli inizi del Trecento, a quando la Sicilia era terra del regno di Federico II d’Aragona. Consacrata nel 1340 anche se non ancora ultimata, la Cattedrale conserva al suo interno opere di notevole valore, come la Cappella di San Crispino, sede della Confraternita dei Calzolai, un tetto ligneo dipinto, vera rarità per la Sicilia del Quattrocento, la Cappella del Redentore, con il trittico marmoreo del Redentore realizzato dal celebre Antonello Gagini, autore anche del fonte battesimale situato nella navata di sinistra.
Castello di Pietratagliata
Aidone, Sicilia
I ruderi del Castello di Gresti hanno il fascino tipico dei luoghi misteriosi, di cui si sa poco o niente ma che sanno di vissuto. Di proprietà privata da lungo tempo, è noto sin dal XIV secolo, quando fungeva da avamposto al centro del “triangolo” compreso fra Aidone, Valguarnera e Raddusa. L’edificio, composto da un torrione e da una serie di stanze ingrottate, da cui deriva l’appellativo di Castello di Pietratagliata, sorge su una cresta rocciosa di natura arenitica, a cavallo del torrente Canne o Gresti, a cui fa da diga naturale. La piana ai suoi piedi spazia all’infinito, in un territorio incontaminato pressoché privo di costruzioni.
A questa fortezza è legato il ricordo di un’antica leggenda che ancora si tramanda: un tempo, sulla facciata dell’edificio c’era un’epigrafe di difficile interpretazione che, una volta tradotta nel modo corretto, avrebbe consentito al fortunato cavaliere di trovare un grande tesoro. La realtà narra che nell’800 furono rinvenute sulla collina parecchie monete d’argento e di elettro coniate da una zecca dell’età punica. Forse, anche in virtù di questi ritrovamenti, la leggenda continua a suscitare proseliti e ad alimentare speranze di trovare tesori segreti.
Dove dormire
Scopri l’eccellenza italiana dell’Ospitalità. I migliori hotel, B&B, agriturismi, campeggi, country house e rifugi selezionati per te e certificati per la qualità dei servizi.
Scopri tuttiDove mangiare
Scopri l’autentica cucina del territorio e vivi un’esperienza unica nei ristoranti e negli agriturismi di eccellenza certificati Ospitalità Italiana.
Scopri tutti