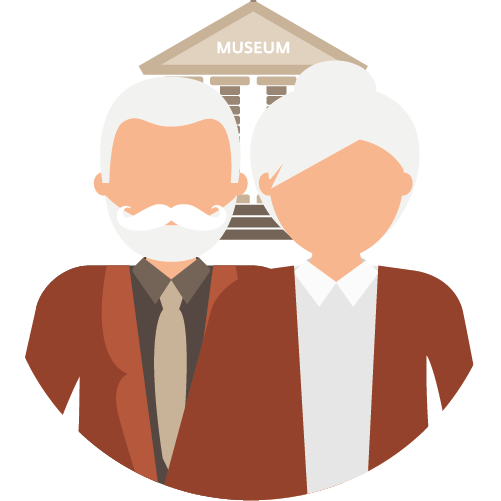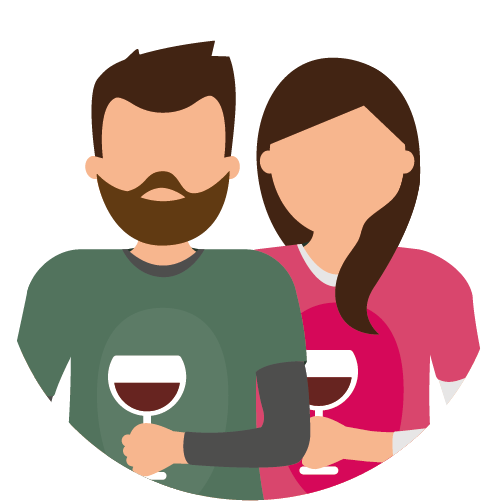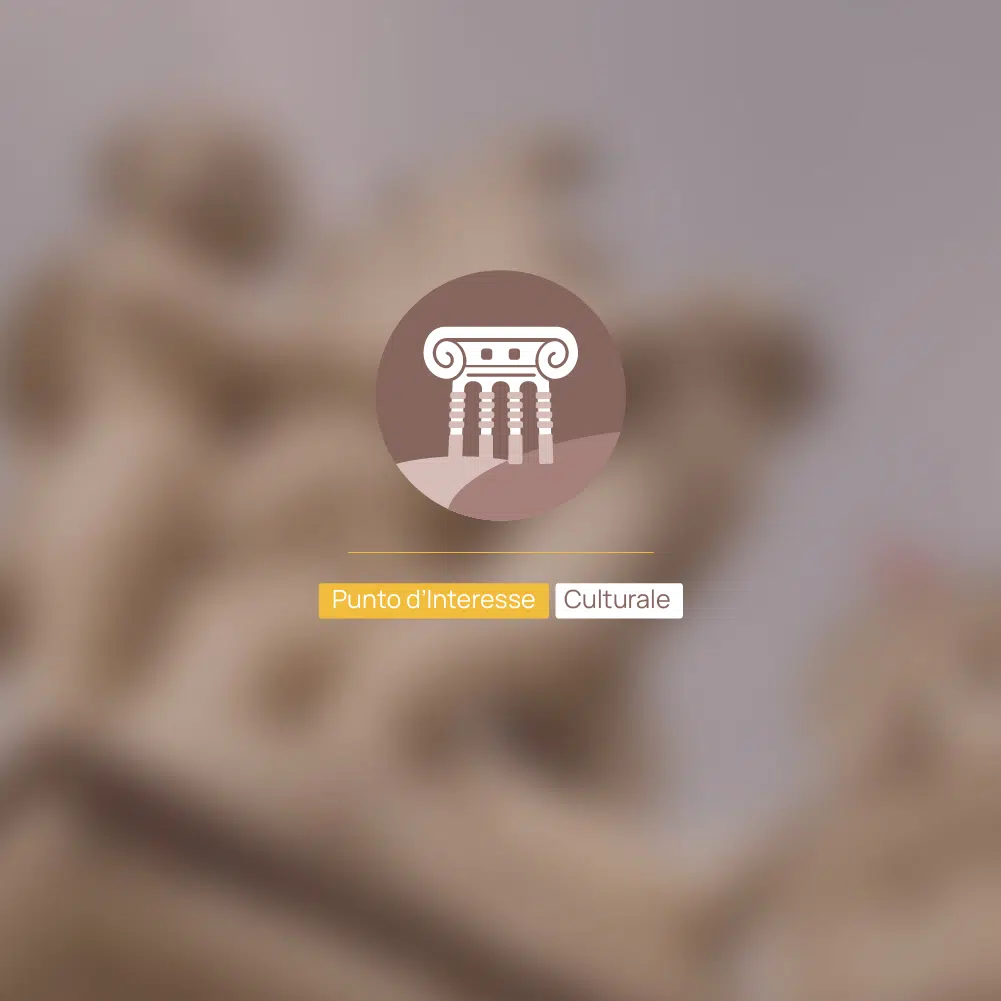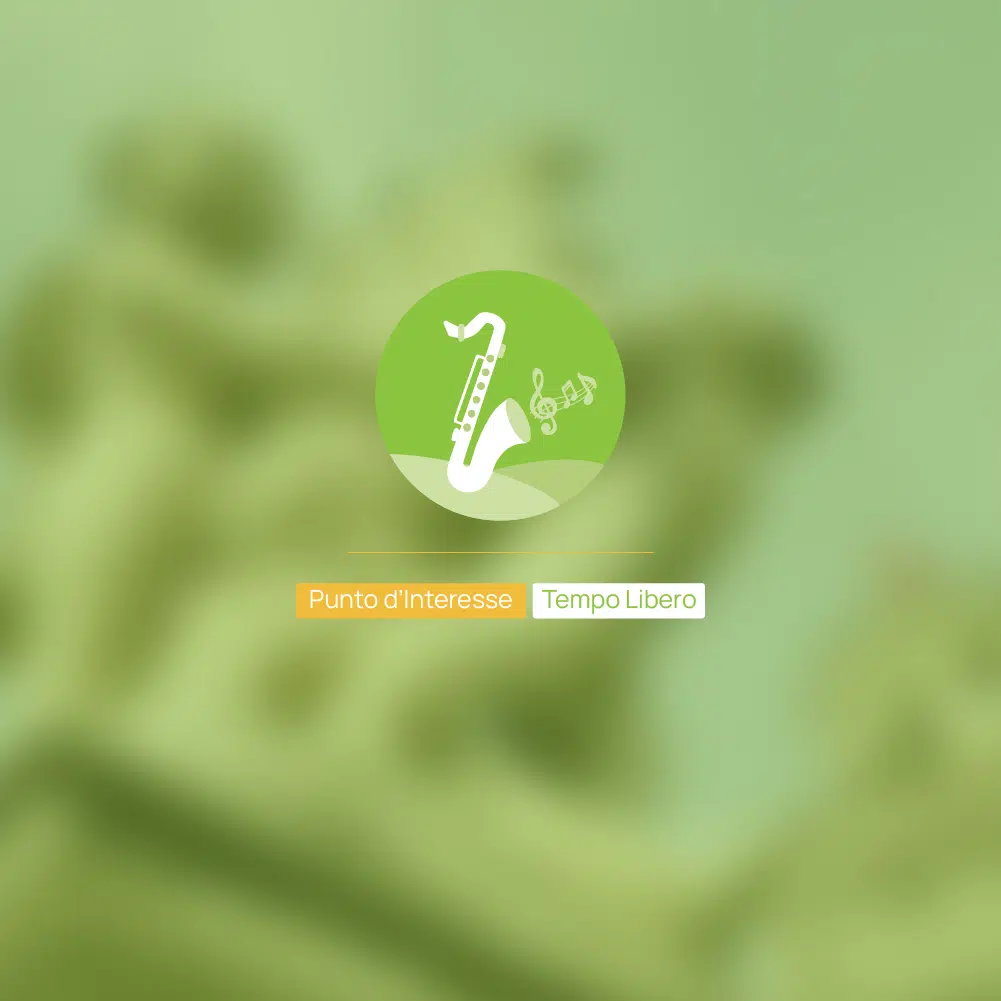accadia, alberona, anzano di puglia, ascoli satriano, biccari, bovino, carlantino, casalnuovo monterotaro, casalvecchio di puglia, castelluccio dei sauri, castelluccio valmaggiore, castelnuovo della daunia, celenza valfortore, celle di san vito, deliceto, faeto, lucera, monteleone di puglia, motta montecorvino, orsara di puglia, panni, pietramontecorvino, rocchetta sant'antonio, roseto valfortore, sant'agata di puglia, troia, volturara appula, volturino
Scopri tutti i comuni del territorioDal Promontorio del Gargano al Vulture, dal Subappennino al Golfo di Manfredonia, abbracciando l’intero Tavoliere delle Puglie. I confini della Daunia la iscrivono in un territorio di dolci colline, foreste di querce e faggete, distese di campi disseminati di paesini di pietra.
Tra i borghi dei Monti Dauni ne è un esempio Biccari, riconoscibile da lontano per la sua torre bizantina e per l’area naturale Lago Pescara – Monte Cornacchia – Borgo Cerasa che offre la possibilità di svolgere numerose attività all’aperto, tra cui percorrere sentieri che portano sulla vetta più alta della Puglia (1151 mt), percorrendo i centri di Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto e Roseto Valfortore, dove è possibile scorgere i resti di splendidi e antichi mulini ad acqua. Qui è presente, inoltre, l’unica comunità franco-provenzale dell’Italia Meridionale.
Nell’Appennino Dauno settentrionale si fa sosta ad Alberona, Volturino e Volturara Appula, immersi in una rigogliosa vegetazione e noti per l’ottima cucina locale, rustica e dai sapori decisi. E ancora, Motta Montecorvino con il campanile in stile gotico e Pietramontecorvino, dove nel cuore del centro storico sorge un bel palazzo ducale di origine normanna. Castelnuovo della Daunia è un ottimo centro termale, Casalvecchio di Puglia conserva il dialetto di una comunità albanese del XV sec., mentre nei pressi di Casalnuovo Monterotaro sorgono i ruderi del castello edificato intorno al IX secolo. Carlantino, Celenza Valfortore e San Marco la Catola, invece, si affacciano sul più grande lago artificiale d’Italia, l’invaso di Occhito, che segna il confine con il Molise.
Sul versante meridionale dei Monti Dauni, la tappa è Troia, contesa da Romani e Cartaginesi e conosciuta per la sua bella Cattedrale romanica sulla cui facciata principale è incastonato un rosone a undici raggi, unico al mondo. Origini antiche anche per Orsara di Puglia, che per tutto il XIII secolo ebbe nel Palazzo Baronale la sede principale dei Cavalieri dell’Ordine di Calatrava, mentre oggi nel periodo estivo è scenario del rinomato Orsara Jazz. Nelle vicinanze, la verdissima Panni, che deve forse il suo nome a Pan, dio delle montagne e dei boschi.
Vicino Bovino sorge il duecentesco Santuario di Santa Maria di Valleverde, mentre a Deliceto è presente un Castello a pianta quadrangolare che ricorda le stratificazioni storiche avvenute al passaggio di Normanni e Aragonesi. Maestoso il Convento di Santa Maria della Consolazione, dove vissero per lungo periodo Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo Maiella. Fra sacro e profano, proprio qui ai primi di agosto è organizzata ogni anno la giornata del maiale nero dei Monti Dauni, tra giochi, balli, tradizioni e musica popolare.
Sant’Agata di Puglia, dalla cima del suo colle, offre uno dei più bei panorami di tutta la Capitanata e per questo motivo viene definito la “loggia delle Puglie”. Buoni motivi di visita sono anche il castello, le molte chiese, i palazzi nobiliari, il Convento di Sant’Antonio e un antico frantoio del ‘500 situato all’interno di una grotta. Hanno un vago richiamo dolomitico i panorami che si godono invece dalla medievale Accadia, sul crinale del Monte Tre Titoli, specie in prossimità della Gola di Pietra di Punta, un insieme di rocce carsiche che precipitano per circa 150 mt. formando giochi d’acqua spettacolari. Al confine con l’Irpinia, Monteleone di Puglia e Anzano di Puglia danno il meglio di sé a tavola, con formaggi e caciocavalli dal sapore inconfondibile.
Posti a sud del sub-appennino si trovano i borghi di Rocchetta Sant’Antonio con la particolare torre del castello del XV secolo a forma di prua di nave, e Candela, dove è possibile ripercorrere le antiche stradine della transumanza. Ancora qualche chilometro ed ecco Ascoli Satriano, sede del Parco Archeologico dei Dauni e del Polo Museale, dove poter ammirare un tesoro di inestimabile valore artistico, storico, culturale e archeologico, ossia i Grifoni. Qui vicino risiede anche la Villa romana di Faragola, con i suoi preziosi marmi e mosaici, l’imponente impianto termale e la lussuosa cenatio, e con stratificazioni che coprono 14 secoli, dal IV a.C. fino al IX d.C.
Merita un approfondimento Lucera, definita “la porta dei Monti Dauni”, perla di rara bellezza per chiunque ami l’architettura. Nota per ospitare la Cattedrale dell’Assunta in stile gotico, la fortezza svevo-angioina e l’anfiteatro augusteo. La città ha origini antichissime, notevole è la presenza di reperti di epoche diverse: resti che vanno dall’età neolitica all’età del bronzo, testimonianze di epoca greca, dauna e reperti di epoca romana e di età moderna.
E gli altri turisti cosa ne pensano?
Scopri le tre cose apprezzate di più da chi ha già visitato la destinazione
Dati ottenuti tramite l’analisi delle recensioni sul web
Cerca per
2 elementi Cosa fare e vedere
Fortezza Svevo-Angioina di Lucera
Lucera, Puglia
Capanne neolitiche, resti del periodo romano, paleocristiano, svevo e angioino. Passeggiare sul Colle Albano di Lucera, in provincia di Foggia, è come leggere un libro di storia. A ogni strato corrisponde una civiltà, in un susseguirsi di emergenze archeologiche e architettoniche che rendono prezioso questo lembo di Puglia. Fra i lasciti più importanti c’è di sicuro la Fortezza svevo-angioina di Lucera, detta anche Castello di Lucera, in una posizione strategica dominante sul Tavoliere di Puglia. La funzione originaria della fortezza doveva essere quella di ospitare il Palatium di Federico II, il palazzo imperiale del quale oggi purtroppo si possono ammirare soltanto alcuni resti, che a tratti ricordano la struttura ottagonale del celebre Castel del Monte ad Andria, altro capolavoro di ingegneria militare di epoca federiciana. Il Palatium, realizzato attorno al 1233, cinquant’anni più tardi veniva inglobato nella fortezza costruita in seguito all’assedio della città da parte di Carlo I d’Angiò, con una cinta muraria di circa 900 metri di perimetro, 13 torri quadrate, 2 bastioni pentagonali, 7 contrafforti e 2 torri cilindriche angolari, la Torre “della Leonessa” e la Torre “del Leone”.
All’interno delle mura, sfruttando anche materiali prelevati dalle costruzioni romane della zona, venne poi realizzata una vera e propria cittadella militare, con case, caserme, una cisterna e una chiesa gotica. Un microcosmo che, poco dopo, attorno al 1300, venne messo sotto assedio e distrutto, per poi rinascere nel XIX secolo grazie a importanti lavori di restauro ed essere dichiarato Monumento nazionale nel 1871.
Fucacost e Cocce Priatorije
Orsara Di Puglia, Puglia
La carne e il pane arrostiti, il grano cotto con il mosto cotto e ancora patate, cipolle e castagne. A Orsara, nel cuore della Daunia, in provincia di Foggia, nella notte tra il 1° ed il 2 novembre il menu lo stabilisce un’antica tradizione legata alla festività dei morti, per certi aspetti simile ad Halloween, ma con delle tipicità che non lasciano dubbi sull’origine pugliese. Per le strade del borgo si accendono i “fuca cost”, i fuochi di rami di ginestra usati per purificarsi nell’attesa della “visita” delle anime dei cari defunti. Secondo la credenza popolare, infatti, i defunti, percorrendo le strade e i luoghi a loro familiari, si possono così riscaldare, guidati dalle zucche svuotate e intagliate a forma di testa (cocc priatorije), appese accanto all’ingresso delle case. Da qui l’usanza di allestire dei banchetti per festeggiare il ritorno dei defunti.