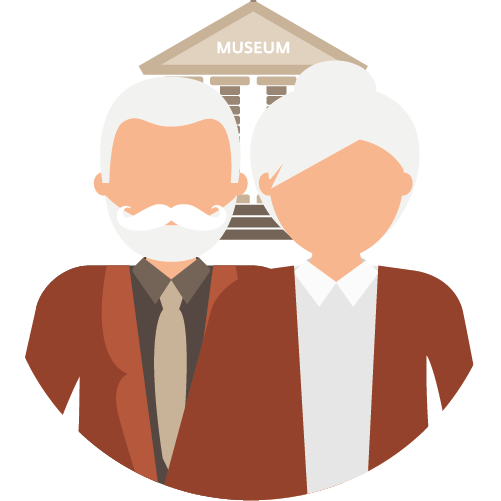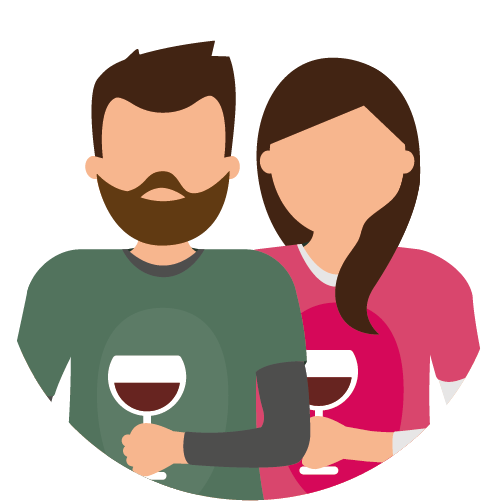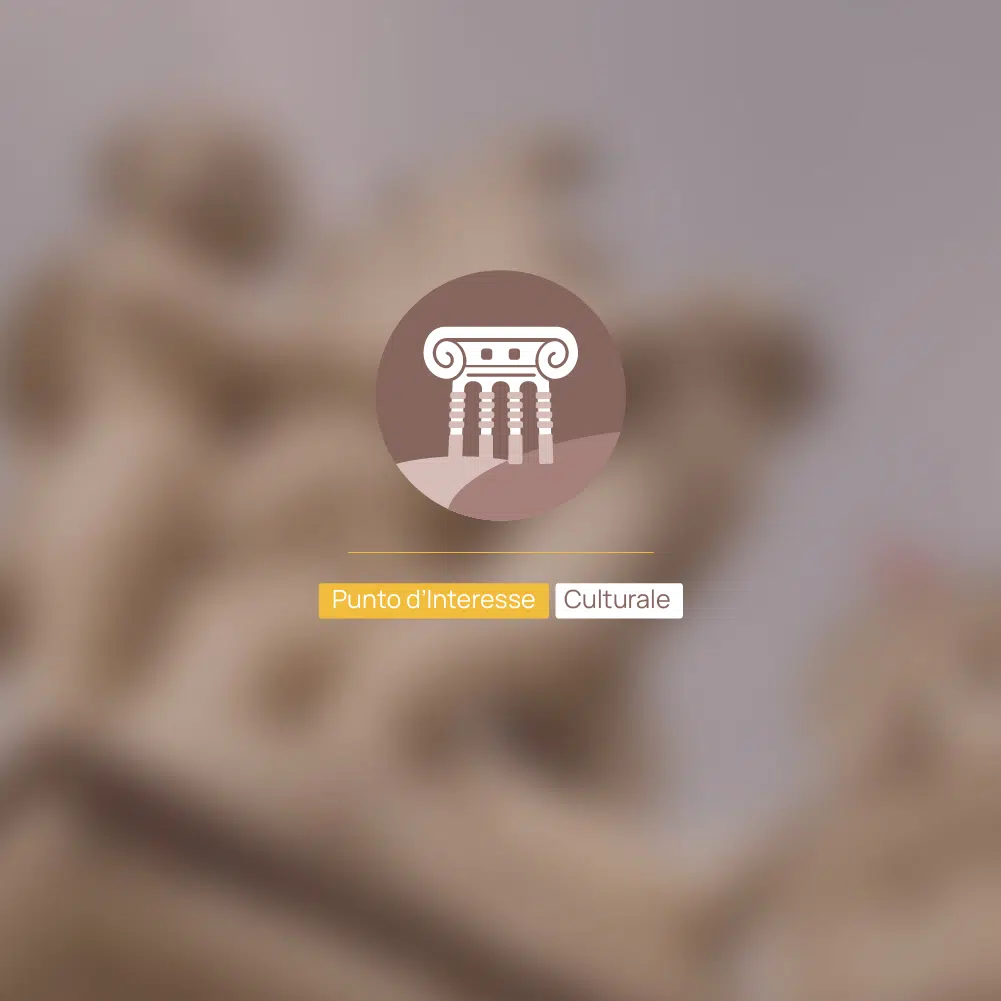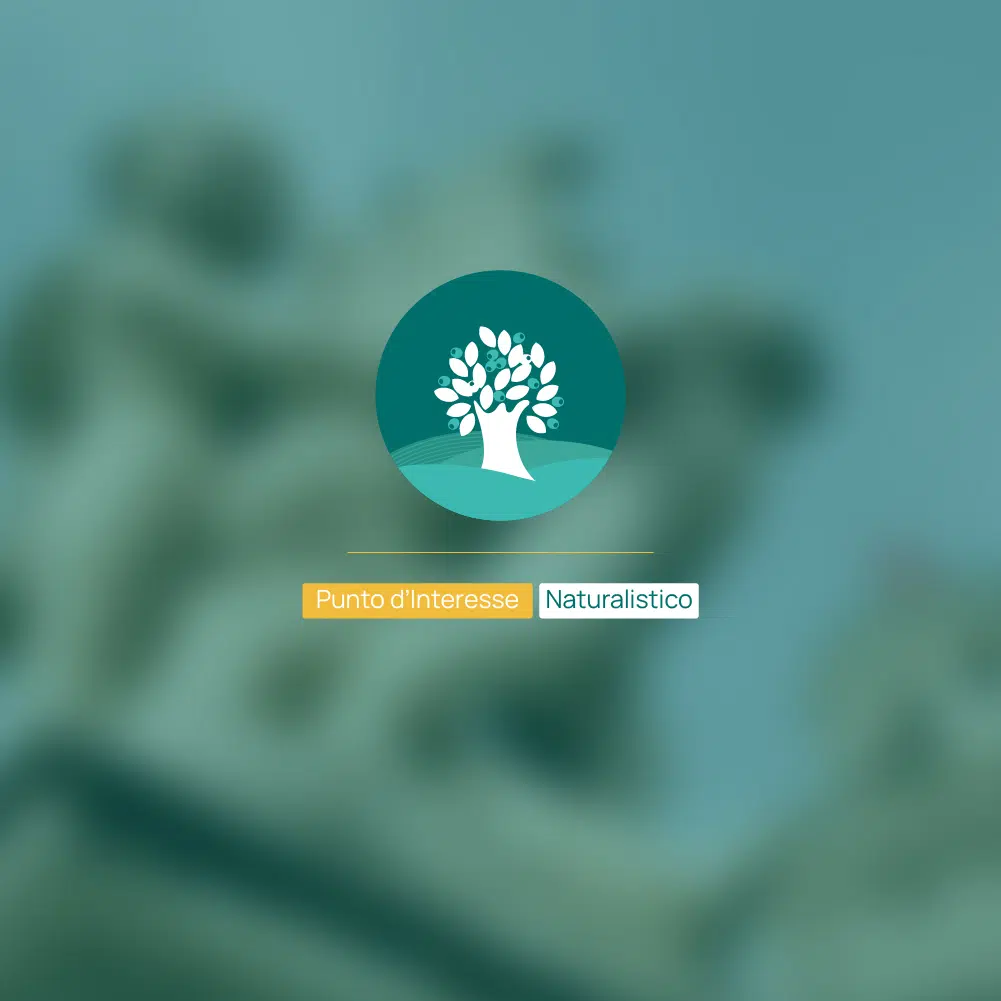Le attività del turista Culturale
cultura materiale (città d'arte, siti archeologici, musei)
Nascita, vita e morte si ritrovano l’una accanto all’altra nella Piazza dei Miracoli di Pisa, rispettivamente rappresentati da Battistero, Cattedrale e Campo Santo Monumentale. A latere, ma protagonista di questo straordinario insieme architettonico, la celebre Torre Pendente. Dedicato a San Giovanni Battista, il Battistero è il più grande d’Italia con una circonferenza di 107,24 metri e un’altezza di 54 metri e 86 centimetri, che gli attribuiscono un’eco singolare e un’acustica eccezionale tali da trasformarlo in un vero e proprio “strumento musicale”. Al centro della Piazza, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, in stile romanico pisano con influenze bizantine e arabe, rappresentava qualcosa di nuovo nel panorama architettonico dell’epoca, grazie alla policroma della facciata e all’uso del loggiato. E una volta all’interno, ecco l’abside con il mosaico di Cimabue e il pergamo di Giovanni Pisano, considerato il capolavoro del gotico italiano, la tomba dell’imperatore Enrico VII di Lussemburgo, collocata dietro l’altare maggiore, nell’abside, a dimostrare la devozione dei Pisani ghibellini per l’Imperatore del Sacro Romano Impero.
Poi, la Torre Pendente, che non ha bisogno di spiegazioni neanche per quello strano fenomeno che la regge ancora in piedi da quel lontano 1173. Pensata come campanile staccato dalla Cattedrale, mostrò i primi problemi statici sin dall’inizio dei lavori, quando si arrivò a costruire il terzo anello. Così, da lì in su, gli anelli furono costruiti con piani leggermente storti per controbilanciare la pendenza. Nel corso degli ultimi decenni, dopo un’importante opera di consolidamento, la torre è stata riaperta al pubblico e una volta percorsi i 294 gradini, la vista si apre su tutta Pisa e la campagna circostante. Il Camposanto Monumentale ha la funzione di cimitero della Cattedrale e ospita le sepolture dei pisani più illustri, inumati nella terra di Gerusalemme portata dai Pisani di ritorno dalla Crociata in Terra Santa. In tempi più recenti, nel 1944, una bomba dell’artiglieria americana ne colpì il tetto provocando un incendio, che danneggiò il ciclo degli affreschi medievali, poi portati via con la tecnica dello “strappo”. Questa tragedia permise però un’importante scoperta: quella delle sinopie, i disegni preparatori in ocra rossa sottostanti agli affreschi. Recentemente, il ciclo di affreschi “Il Trionfo della Morte“ (1336-1341) è stato ricollocato in parete al Cimitero Monumentale a seguito di un lungo e delicato restauro.
Vicino al Camposanto si trova il Museo delle Sinopie, dove sono conservati i disegni preparatori degli affreschi realizzati da Bonamico Buffalmacco (autore del Trionfo della Morte), Taddeo Gaddi e Pietro di Puccio da Orvieto, che iniziò il ciclo delle Storie del Vecchio Testamento, portato a termine da Benozzo Gozzoli. Il Museo dell’Opera del Duomo ospita invece una splendida collezione della produzione scultorea pisana realizzata tra XI e XIV secolo, il tesoro della Cattedrale, le statue e reperti rimossi per restauro dai monumenti di Piazza dei Miracoli.
La Piazza dei Miracoli di Pisa è tutt’oggi protetta dalla cinta delle Mura Medievali, percorse da un camminamento di ronda di 6 km di cui 3 sono stati recentemente riaperti al pubblico, pronti a regalare prospettive insolite della città e della piazza stessa. Al di là di questa cortina di difesa sfruttata oggi come belvedere si possono scoprire gli altri luoghi d’arte di Pisa. Negli Arsenali Medicei trova degna collocazione il bellissimo Museo delle Navi Antiche con 800 reperti esposti in 8 sezioni rinvenuti nel 1998 durante i lavori alla stazione di San Rossore. Dal suolo tornarono alla luce trenta imbarcazioni in ottimo stato di conservazione di epoca romana e migliaia di reperti tra vasi, anfore, metalli, materiali organici, tanto che Pisa fu ribattezzata la “Pompei del mare”. Il cinquecentesco Palazzo Reale, residenza invernale della corte dei Medici, poi dei Lorena Granduchi di Toscana e infine dei Savoia, è invece sede del Museo Nazionale, che attraverso cimeli e opere di ogni genere traccia il percorso di queste tre grandi dinastie. Codici miniati e oltre 200 opere di maestri quali Nicola Pisano, Donatello, Giunta Pisano, Simone Martini e Masaccio sono invece in mostra al Museo Nazionale di San Matteo, il più importante polo di pittura e scultura della città. Appartiene alla Fondazione Pisa il Palazzo Blu, sede della Collezione Simoneschi, con opere di Giuseppe Viviani e saloni finemente arredati in stile settecentesco con mobili d’epoca e vista sui lungarni.
Altra chicca in città sono l’Orto e il Museo Botanico, fondato nel 1543 dal naturalista, medico e botanico Luca Ghini, ignaro allora di realizzare il primo orto botanico universitario del mondo. L’attuale sede risale al 1591, mentre quella originaria si trovava sulle rive del fiume Arno. Ampliato nel tempo, oggi occupa circa due ettari con una collezione di piante dei cinque continenti: le succulente dei deserti africani e americani; le piante aromatiche della macchia mediterranea; le specie delle paludi toscane; numerosi alberi secolari e tante altre.
Negli ambienti di Palazzo Lanfranchi si trova il Museo della Grafica, punto di riferimento della grafica contemporanea, con opere di Sebastiano Timpanaro, Carlo Ludovico Ragghianti e Giulio Carlo Argan. Chiudono questa carrellata di luoghi dedicati all’arte tout court le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa, polo di fama internazionale per l’importanza dei suoi reperti, specialmente quelli provenienti dall’area dell’antica Nubia. L’origine di questo tesoro si deve al pisano Ippolito Rosellini, “padre dell’egittologia italiana”, che insieme al francese Champollion guidò nel 1828 la spedizione in Egitto e Nubia, rivelatasi poi fondamentale per lo studio dell’antico Egitto.
Le attività del turista Enogastronomico
Enogastronomia
Con tre prodotti di alta qualità come l’olio extravergine d’oliva, il vino e il tartufo, le Terre di Pisa possono dirsi una destinazione per “gastronauti”, da gustare passo a passo, lentamente, seguendo la comoda traccia delle strade dei sapori. L’approccio potrebbe avvenire con la Strada dell’Olio dei Monti Pisani, che corre lungo il versante pisano del Monte e attraverso cinque Comuni: Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano. Luoghi che richiamano arte, natura e gusto Made in Tuscany, cui si aggiunge il relax donato da un bagno alle storiche Terme di San Giuliano e da un’infinità di strutture ricettive più o meno country style in grado di soddisfare ogni genere di richiesta e di budget. E dopo la remise en forme a San Giuliano Terme, è d’obbligo la visita alla maestosa Certosa di Calci, così come una degustazione di olio locale in una delle tante aziende situate fra Buti e Vicopisano, borgo noto anche per la tradizionale lavorazione della ceramica.
Aziende ed enti locali sono artefici anche della Strada del Vino e delle Colline Pisane, concepita con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio e i prodotti di eccellenza gravitanti attorno alla Torre Pendente. Qui si va da Valdera a Valdarno inferiore, abbandonandosi alla contemplazione di un paesaggio capace di stupire per varietà, colori e qualità dei prodotti della terra. Grano dorato, peschi, ciliegi, vigneti, macchia mediterranea…Una palette cromatica infinita che ammalia e invita a proseguire il viaggio intrecciando la Strada del Vino alla Via Francigena e al Grande Percorso Naturalistico (GPN) delle Colline Pisane, tra centri ricchi di storia e di cultura, romantici borghi e imponenti casali. Lo stop è doveroso al Museo Piaggio dedicato alla Vespa e al Teatro del Silenzio a Lajatico, punto di riferimento della grande musica internazionale fortemente voluto e ora guidato da un Presidente onorario speciale, il maestro Andrea Bocelli.
Le suggestioni continuano verso San Miniato, fra Palaia e Peccioli, e poi verso le balze di Volterra, lungo il tracciato detto “la Via dei Tartufi“. San Miniato, da secoli tappa obbligata dei pellegrini lungo la Via Francigena, si fa vanto di un bel Centro Storico e di aver visto nascere una delle prime Associazioni del Tartufo in Italia, quella dei Tartufai di San Miniato. Il borgo ospita ogni anno a novembre la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, che per tre fine settimane propone le eccellenze del territorio. E’ invece possibile sempre, tutto l’anno, organizzare un’autentica caccia al tartufo con cane e tartufaio nel Parco del tartufo presso Villa Sonnino, appena fuori l’abitato. In zona, e precisamente a Corazzano, Cigoli, Balconevisi e Ponte a Egola, si svolgono altre sagre più o meno a tema gastronomico, alcune con qualche risvolto curioso, come per esempio il Palio del Papero di Balconevisi.
Tornando al tema principe della Via dei Tartufi, a Palaia, dove è consigliata la visita alla Pieve romanica di San Martino, è diffusa soprattutto la specie del Bianco, il Tuber Magnatum Pico, e del Tartufo Bianchetto o Marzuolo, la cui stagione va da gennaio ad aprile. Nella campagna attorno si trovano due paesi disabitati che meritano una sosta, Villa Saletta e Toiano, così come Montefoscoli, con il Museo della Civiltà Contadina e lo strano Tempio di Minerva Medica famoso per i simboli massonici ed esoterici che rimandano a personaggi misteriosi e affascinanti. Se a Palaia ha sede l’azienda Savini Tartufi, attiva da quattro generazioni, a Ghizzano c’è Tartufi di Teo, che ha realizzato una filiera corta al tartufo proponendo l’esperienza di una caccia al tartufo con la degustazione finale in azienda. Meritano poi una deviazione l’azienda Tenuta di Ghizzano, dove si visita l’originale Giardino Sonoro, e il borgo di Peccioli, trasformato in una galleria d’arte open air, mentre per i bambini ci sono il Parco Avventura Urbano “Pecciolo Avventura” e il Parco Preistorico.
Infine, l’etrusca Volterra, città rimasta architettonicamente al Medioevo e resa famosa oltre che per la lavorazione dell’alabastro per l’Associazione Tartufai dell’Alta Val di Cecina che ne tutela il prezioso Tuber. L’annuale rassegna gastronomica Volterra Gusto celebra il tartufo Marzuolo, quello nero e quello bianco, mentre le locali aziende offrono l’esperienza di indossare i panni del trifolao, nella speranza di trovare un bel bottino da gustare poi a tavola.
Le attività del turista Naturalistico
turismo termale
Etruschi e romani lo sapevano bene che nelle Terre di Pisa si nascondeva un tesoro: le acque termali di numerose sorgenti, da allora sfruttate a pieno regime in stabilimenti all’avanguardia in ogni epoca. A San Giuliano Terme c’è Bagni di Pisa, realizzato a fine Settecento con un’allure sontuosa come si conveniva alla residenza del Granduca Francesco di Lorena. Di particolare interesse sono anche gli ambienti interni, le suite dedicate ai molti personaggi celebri passati di qui, per le cure, per vezzo, per mondanità.
L’Hamman dei Granduchi, una piccola grotta naturale dove l’acqua termale affluisce da una cascatella, è il cuore della Spa, dove si possono effettuare massaggi, trattamenti e bagni nelle piscine termali. C’è anche un Giardino Zen, con una Kaffee Haus da cui si domina la pianura fino a Pisa
Cure idropiniche si possono fare anche a Uliveto Terme, lungo la strada del Monte Pisano, nel cui parco ci sono una piccola chiesa romanica, dedicata a San Martino al Bagno, location di matrimoni e cerimonie, e la piscina comunale (non termale) di Uliveto, aperta solo nel periodo estivo.
Fra Pisa e Volterra il benessere trova la sua sorgente alle Terme di Casciana, con un centro di cura e riabilitazione all’avanguardia e un centro benessere che si affaccia sulla piscina balneoterapica a 36° di temperatura. Basta attraversare la strada principale di Casciana Terme ed ecco anche le Terme di Villa Borri, una fattoria del Settecento trasformata in un’elegante hotel con Spa. Una curiosità: l’acqua surgiva locale ha pure un nome, Mathelda, la cui origine si fa risalire alla Contessa Matilde di Canossa. Pare che si debba a lei la “scoperta” del potere curativo, che notò come un merlo malato si mise a volare dopo essersi bagnato nelle acque di Casciana. Vero o no, è certo che la prima piscina fu costruita nel 1311, mentre il primo stabilimento a metà Ottocento per volontà del Granduca Ferdinando di Lorena, come ricordano l’elegante facciata, il Gran Caffè con splendidi affreschi e l’ex Casinò, oggi centro convegni.
tur. naturalistico/svago/relax
Sul trenino ecologico, in battello e, per chi ama lo stile d’antan, addirittura in calesse. Il Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massacciuccoli si può visitare anche così, oltre che a piedi e in bicicletta. Cuore di questa vasta area in provincia di Pisa, ampia circa 23.000 ettari, è la Tenuta di San Rossore, ex proprietà della Presidenza della Repubblica, di cui si può ancora ammirare la Villa del Gombo. Oltre a questa chicca dall’allure altisonante, il Parco comprende numerose altre zone intatte e splendidamente selvagge: la Macchia Lucchese, il Lago di Massaciuccoli e l’area lacustre oggi Oasi Lipu, le foreste di Tombolo e di Migliarino e le foci dell’Arno e del Serchio. Ci sono anche tre “enclave” extra parco, vale a dire le Secche della Meloria e gli scogli compresi tra Livorno e l’isola di Gorgona. Nell’insieme, si tratta quindi di un mosaico di paesaggi assai diversificati fra loro, che vanno dalle dune di sabbia litoranee alle grandi e verdissime pinete dell’entroterra, dagli acquitrini ai boschi rigogliosi di macchia mediterranea profumata, il tutto fra i Comuni di Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme, Vecchiano, Massarosa e Livorno.
Se la flora è ricca – da scovare la rara drosera, una piccola pianta carnivora, la liana periploca greca, l’orchidea palustre e il bellissimo fiordaliso delle sabbie – lo è altrettanto la fauna, che nelle zone umide, in dialetto “lame”, comprende uccelli di palude, trampolieri e aironi, mentre nel bosco daini e cinghiali.