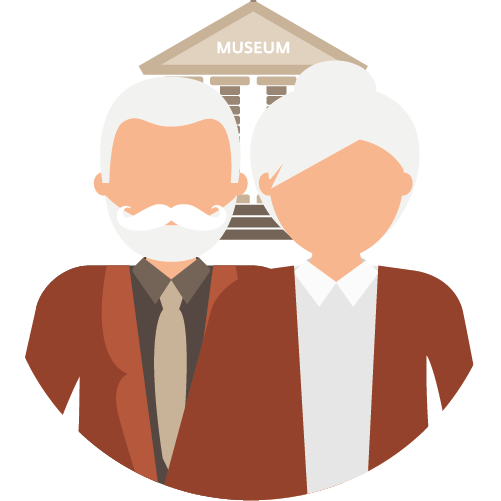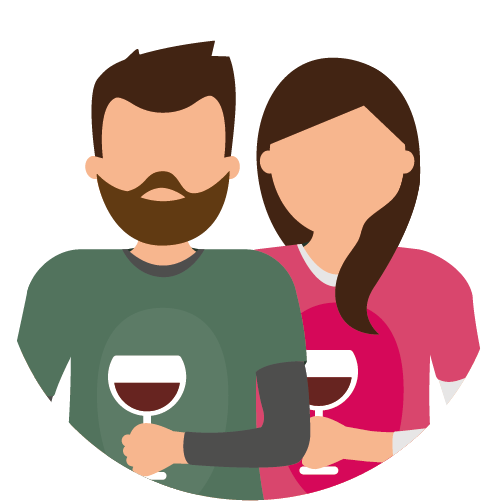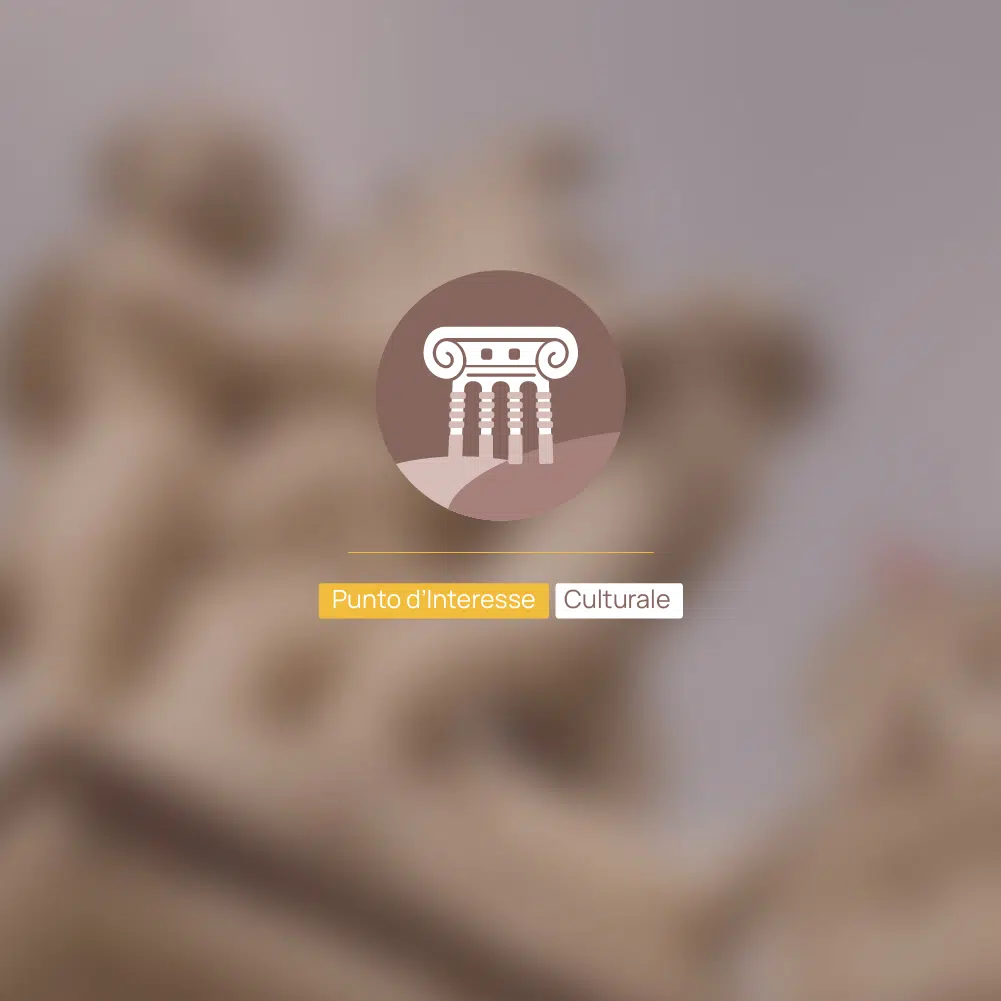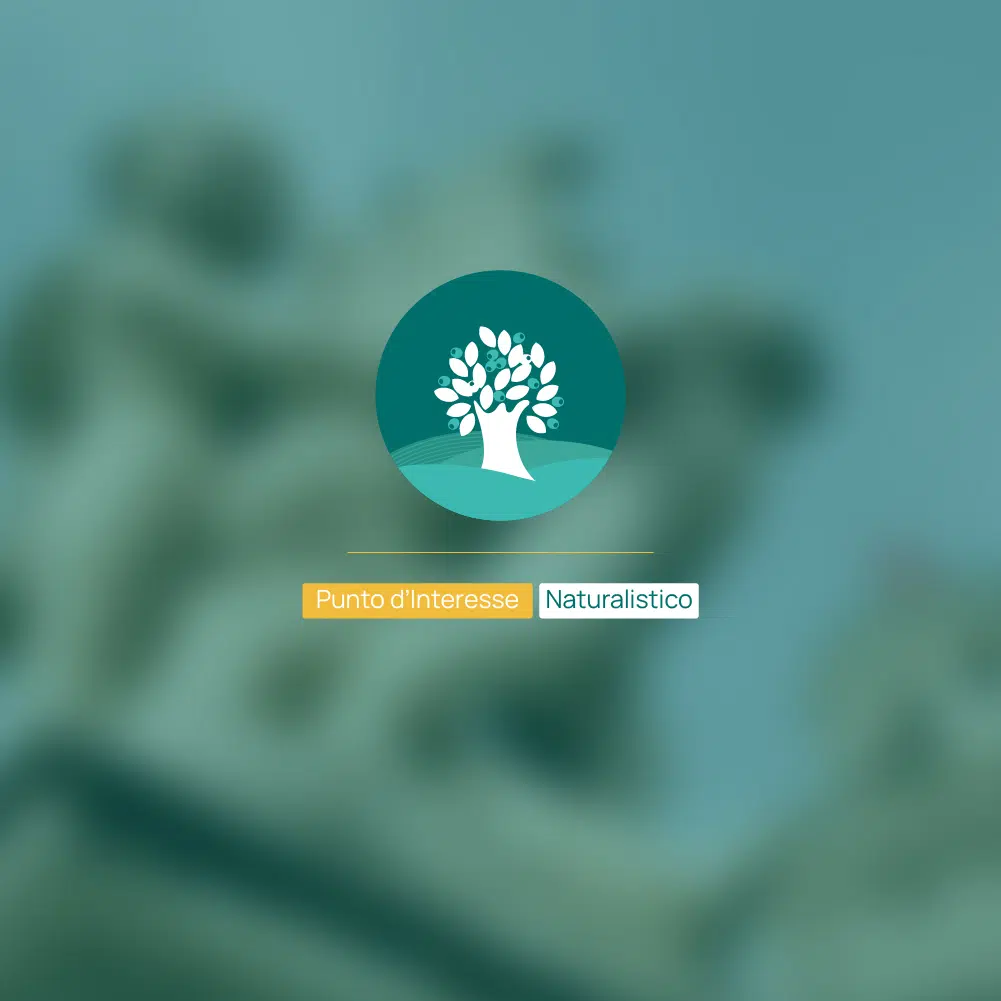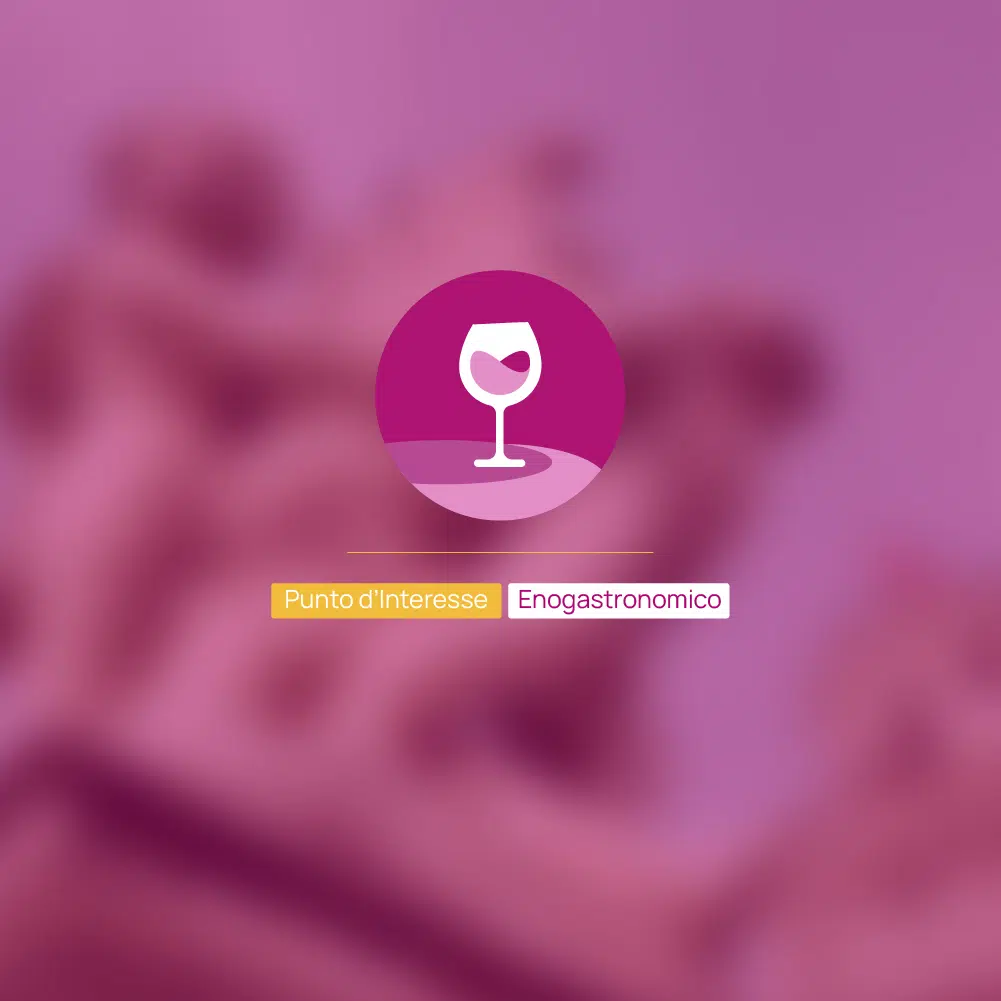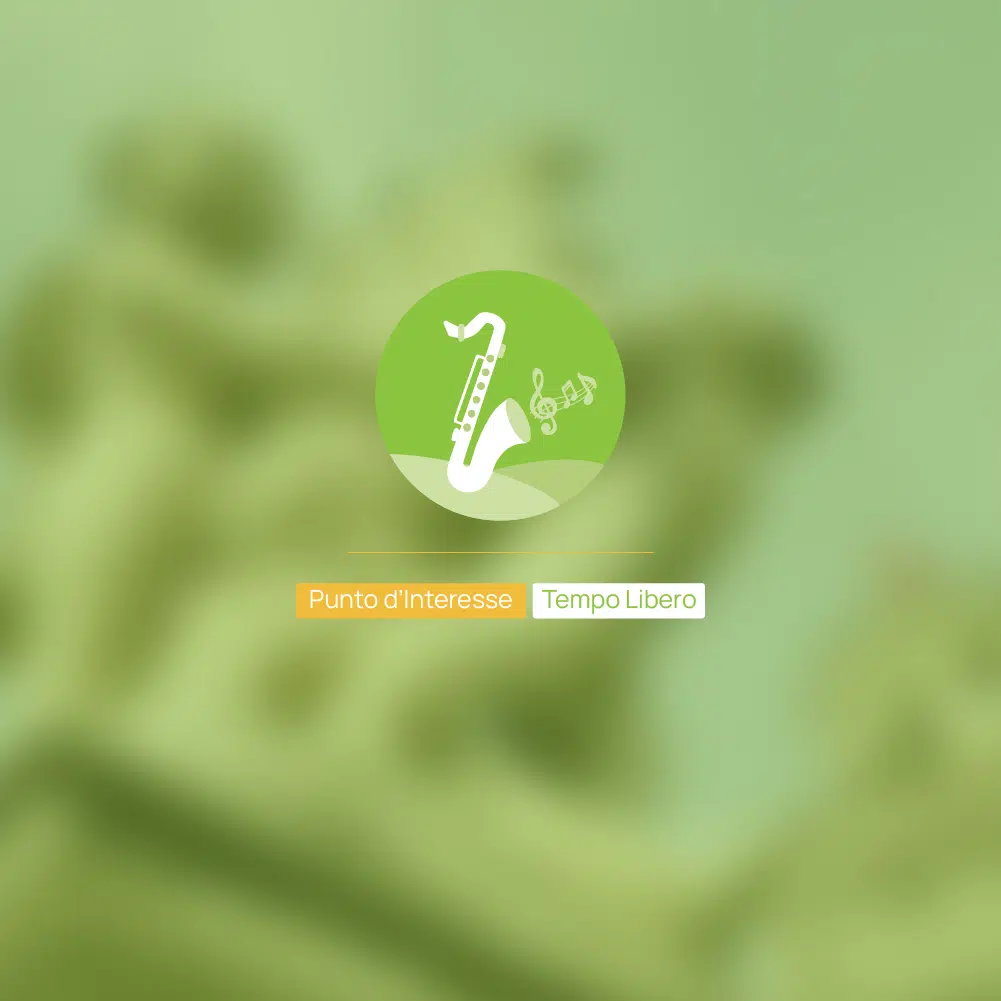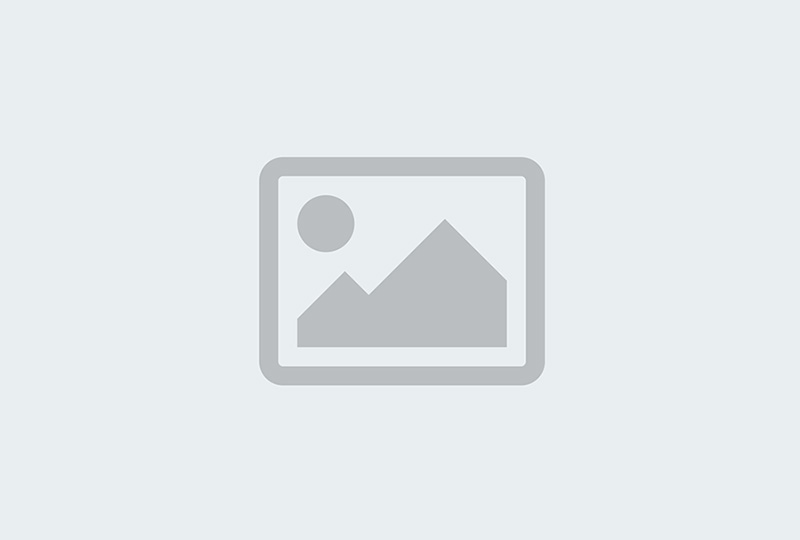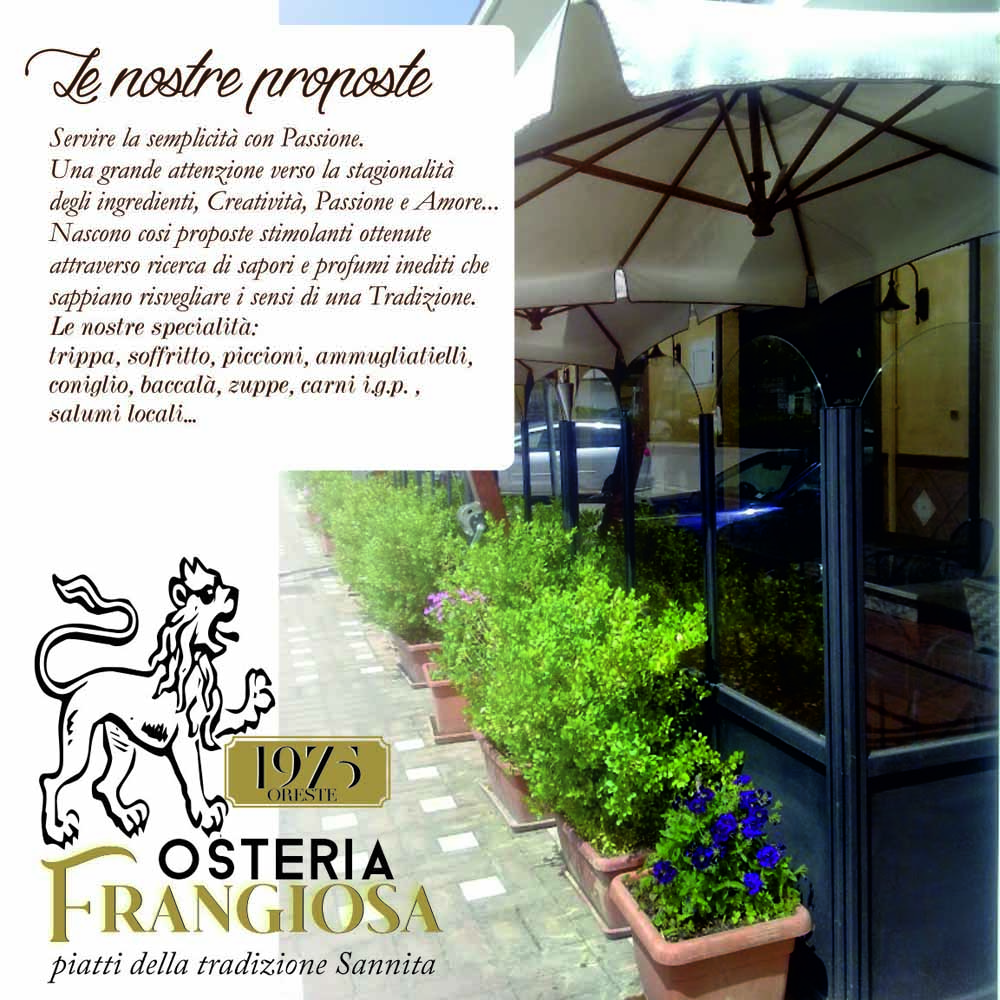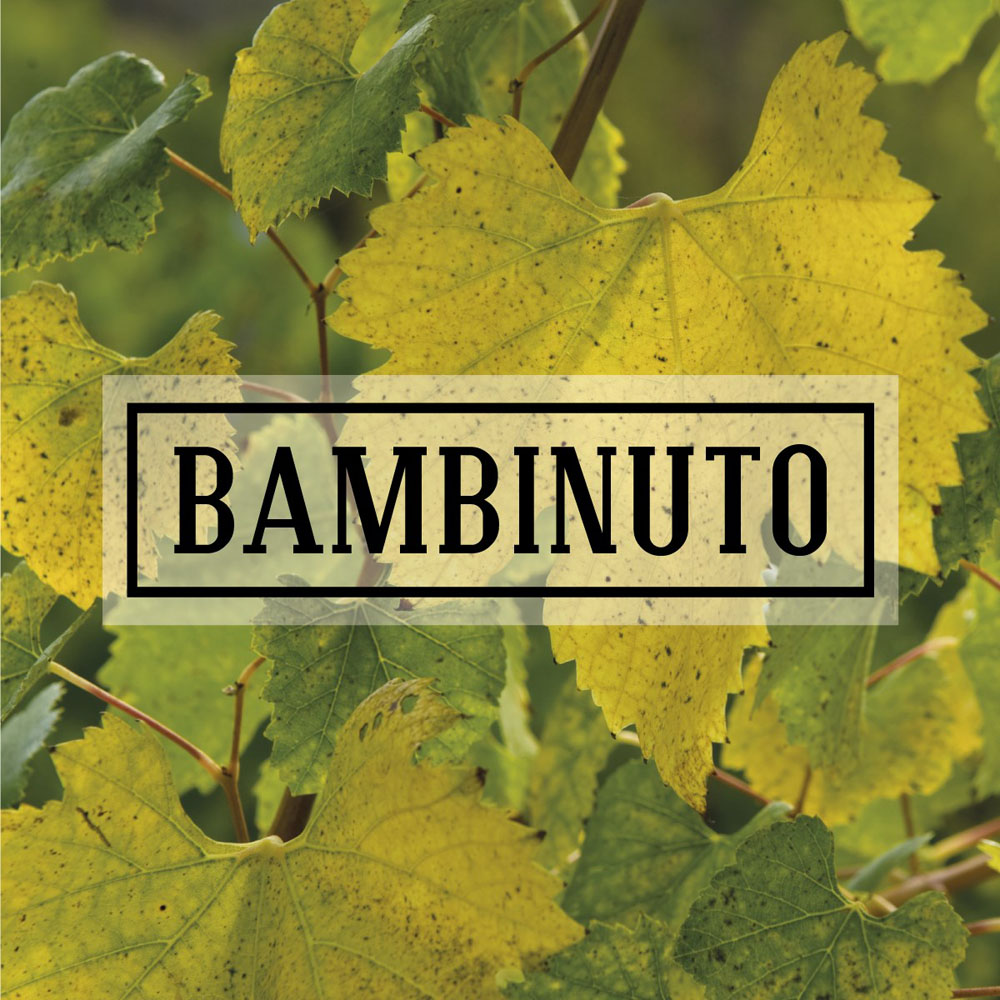Data della prima scoperta, 1748. Data del più recente rinvenimento, estate 2022. Pompei, come la Campania tutta, non smette mai di stupire. In ogni epoca ha regalato sempre soddisfazioni ai suoi molti studiosi e visitatori. Lo faceva nel Settecento, da fulcro dell’immancabile Grand Tour d’Italie che artisti, letterati, scienziati e aristocratici di tutta Europa compivano per abbeverarsi alla fonte delle molte antichità del Bel Paese, e lo fa ancora oggi, aprendo ogni tanto qualche nuovo spiraglio su quella civiltà ferma alla notte del 24 agosto del 79 d.C.. Quell’attimo fuggente che sigillò sotto metri di lava e lapilli una città intera con tutti i suoi abitanti, atroce destino che accomunò migliaia di persone ma che ha permesso a generazioni di archeologi, da quei primi fortunati scopritori al soldo di Carlo III di Borbone in poi, di ricostruire abitudini, conoscenze, stile di vita di duemila anni fa.
Alla casata dei Borbone si deve anche un altro dei siti Unesco di cui oggi si può fregiare la Campania, vale a dire la Reggia di Caserta, la “Versailles d’Italia”, che con le sue 1.200 stanze e saloni divisi in quattro parti da due bracci che si tagliano ortogonalmente e si aprono su altrettanti cortili e sul prospetto infinito dei Giardini è non solo uno dei massimi capolavori architettonici e artistici del Settecento, ma è in assoluto la residenza reale del passato più grande al mondo, una sorta di “cittadella” della bellezza in cui lasciarsi andare alla contemplazione delle tante opere in essa conservate. Perdersi al suo interno, nei chilometri di corridoi progettati da Luigi e Carlo Vanvitelli, è fin troppo facile, così come lo è nell’affascinante complesso di San Leucio, antica fabbrica serica nonché modello di industria d’avanguardia ante litteram, le cui pregiate produzioni già allora conquistarono le principali corti europee, da Buckingham Palace al Vaticano. San Leucio, insieme alla vicina Reggia e all’Acquedotto Carolino, altro capolavoro ingegneristico vanvitelliano commissionato dai Borbone, è oggi una tappa irrinunciabile per la conoscenza della Campania, Regione con alcune macro evidenze diventate a buon diritto fra le mete più gettonate d’Italia, ma accanto alle quali si nascondono molte altre perle tutte da scoprire.
Ne è un paradigma perfetto l’Arcipelago Campano, quella magnifica trilogia di suggestioni che ha inizio a Capri, meta d’élite scoperta dall’imperatore Augusto e da Tiberio poi, che vi costruì la mirabile Villa Jovis da cui, fra il 26 e il 37 d.C., governò persino Roma e l’impero. Se Capri, si sa, è l’isola della Grotta Azzurra, della riservata ed esclusiva Anacapri, degli hotel di lusso e dei locali frequentati dal jet set, dei porticcioli e delle calette affollati di yacht da sogno, e se Ischia è la meta delle vacanze benessere, da godersi da soli o in famiglia in uno dei numerosi parchi termali o Spa hotel che attingono dalle falde fanghi e acque medicamentose, Procida è l’isola che prima del 1994, anno di uscita de “Il Postino” di Massimo Troisi, era sconosciuta ai più e che solo nel 2022 ha avuto i riflettori finalmente accesi su di sé grazie al ruolo di “Capitale della Cultura”. Una “novità” o quasi a livello turistico, una meta in più, ma fondamentale, da aggiungere alla lista delle tappe campane.
Guardando poi la costa da qui, si potrebbe puntare a occhi chiusi sulla linea dell’orizzonte ed essere certi che qualunque approdo sarà quello giusto. Per par condicio, la prima tappa potrebbe essere Sant’Agata sui Due Golfi, spartiacque di due realtà distinte ma similari: da un lato il Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina, dall’altro il Golfo di Salerno e la Costiera Amalfitana. Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Pompei, Ercolano e Oplontis da una parte, Positano, Praiano, Furore, Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare dall’altra. Altro non occorre dire, perché non c’è località che non richiami alla mente immagini di monumenti e palazzi aristocratici, spiagge e anfratti rocciosi da cartolina immersi in scorci da immortalare, profumi e sapori da gustare fra vicoli di luoghi incantati. Micro borghi di pescatori talvolta di poche case, che i Monti Lattari alle loro spalle trasformano in perfette Comunità Montane, attraversate da sentieri del Cai che sprofondano nel blu del mare. Al di là di queste cime, parte del cosiddetto Antiappennino campano, ecco la piana della Campania Felix raccontata da Strabone e Plinio il Vecchio, prospera per i ricchi centri di Capua, Atella, Cumae, Baia, Puteoli, Acerra, Oplontis, fino alle più grandi Neapolis e Salernum.
Terra che da allora non ha smesso di coltivare, per così dire, sacro e profano: l’antica Abellium, oggi Avellino, è punto di partenza per un’escursione al Santuario di Montevergine e verso la verde Irpinia, quasi una regione nella regione, grazie a un paesaggio che alterna zone selvagge da esplorare come il Parco del Partenio e l’Oasi del WWF Lago di Conza, o le misteriose grotte del Laceno, alla più placida piana del Dragone disseminata di cantine vitivinicole che di recente hanno portato alla ribalta gli autoctoni Taurasi, Fiano e Greco di Tufo, solo per un primo assaggio. Dal canto suo, Benevento, da città prima romana e poi longobarda qual è, mostra orgogliosa quel mix di culture che la rende unica, con il teatro romano e l’arco di Traiano, fra le massime espressioni dell’arte antica, e il Duomo medievale, oltre al Complesso di Santa Sofia, sito Unesco. Al medioevo deve tanto anche Salerno, che ha il suo cuore nel quartiere sorto in epoca normanna, attorno all’anno mille, di cui rimangono fra le tappe d’obbligo Castel Terracena e il Duomo, Anno Domini 1085. Senza dimenticare, qualche chilometro più a sud lungo la costa, di fare un tuffo nella Magna Grecia, nel Parco Archeologico di Paestum e Velia. Nota anche come Poseidonia in onore del dio del mare, Paestum era in realtà devotissima ad Atena ed Era, cui è dedicato il tempio al centro della vasta area di scavo. Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, quasi al confine con la Basilicata ma sempre in provincia di Salerno, ecco la Certosa di Padula, che con i suoi 51.500 mq di superficie è il più esteso edificio religioso d’Italia nonché, come il Parco stesso, Patrimonio dell’Umanità.
Capitolo a parte merita il capoluogo, la bella Parthenope fondata nel 680 a.C. ed evolutasi poi in Neapolis e infine nella multisfaccettata Napoli. Altera come i suoi molti fortilizi – Castel dell’Ovo, Castel Sant’Elmo, Castel Nuovo e Castel Capuano – santa come le sue chiese, talvolta severe, vedi Santa Chiara e San Lorenzo Maggiore, talvolta opulente e barocche, come la celebre Certosa di San Martino, la Chiesa del Gesù Nuovo e della Pietà dei Turchini. Colta come i suoi teatri, dal San Carlo al Mercadante, dal Bellini al Sannazaro, e i musei di fama internazionale, dall’Archeologico Nazionale al Capodimonte, dal Filangieri al San Martino. Pittorica come Posillipo e l’Opera buffa. Scanzonata e folcloristica come i Quartieri Spagnoli, sfrontata come il lusso delle boutique della Riviera di Chiaia, raffinata come i palazzi aristocratici, da Palazzo Reale in giù. Infine, ecco la “Napoli segreta”, quella nascosta e silenziosa delle tremila grotte e catacombe sotterranee. Un ultimo mistero svelato da raccontare al mondo.
Cerca per
28 elementi Cosa fare e vedere
Paleolab – Museo del Parco Geopaleontologico
Pietraroja, Campania
Alghe fossili e gusci di bivalvi con un diametro fino a 20 cm si trovano inclusi nelle pietre di colore grigio chiaro utilizzate per lastricare strade e piazze di Pietraroja, nel beneventano, e del vicino borgo di Cusano Mutri. Il perché di questo fenomeno è presto detto: nel Cretaceo, Pietraroja era lambito da una laguna. Ora di quella laguna se ne ha traccia nei reperti conservati nel Paleolab – Museo del Parco Geopaleontologico, sistema multimediale che permette al visitatore di viaggiare indietro nel tempo di 100 milioni di anni, per ritrovarsi immersi nell’Oceano Tetide, a quando cioè questa zona della Campania era popolata da pesci, coccodrilli e salamandre, e soprattutto dallo Scipionyx Samniticus, un piccolo di celosaurus di cui è stato ritrovato un esemplare che rappresenta un vero unicum, con gli organi e le fibre muscolari ancora intatti.
Il percorso di visita del Paleolab di Pietraroja ricorda la scena del film Stargate, in cui varcando una soglia ci si ritrova in un’atra era: il viaggio ha inizio con un “ascensore geologico”, una sorta di teletrasporto grazie al quale in pochi secondi ci si ritrova nel Cretaceo. Gli exibit, le scenografie, i filmati e un grande acquario interattivo permettono nelle prime sale del museo di entrare in questo ambiente tropicale e di conoscerne gli abitanti. Il percorso termina con un excursus sulla storia degli esseri viventi sulla Terra ripercorsa attraverso i fossili.
Per stimolare le future generazioni di paleontologi è stato allestito un campo scavi per i bambini che vogliono cimentarsi con le fatiche ma anche le molte emozioni che regala questo mestiere, cui segue un laboratorio didattico dove è possibile, usando forme di gesso, creare un piccolo calco dei reperti esposti.
“
La perla del Sannio – Borgo Sant’Agata de’ Goti
Sant’agata De’ Goti, Campania
“Perla del Sannio“ e “gioiello della Valle Caudina”. I soprannomi di Sant’Agata de’ Goti anticipano già tutto e vanno ad enfatizzare ciò che racconta anche il nome, frutto di una summa dei vari periodi storici che l’hanno interessata: nell’VIII secolo, fu intitolata alla Santa catanese e dunque fu costruita la Chiesa di Sant’Agata de Amarenis, mentre in epoca normanna, intorno al 1117, si aggiunse la seconda parte, con l’arrivo nel territorio di Sant’Agata della famiglia di feudatari francesi Drengot. Ed ecco appunto Sant’Agata de’ Goti.
Anche architettonicamente, la cittadina in provincia di Benevento – il cui Centro Storico è inserito nel circuito de “I borghi più belli d’Italia” – è un perfetto connubio fra lasciti di epoca romana, longobarda e del XIX secolo. Non solo. Dal 2005, grazie alla ricca campagna che la circonda, fa parte dell’associazione Nazionale Città del Vino. Basta fare due passi fuori dall’abitato per ritrovarsi davanti a un’antica masseria, a contrade di case contadine vecchie di secoli.
Il consiglio da conservare, per apprezzare Sant’Agata de’ Goti nel suo insieme, è di andare sul ponte del torrente Martorano: da qui si può notare come il Centro Storico sorge su un promontorio di tufo che ricorda una mezzaluna, materiale fra i più friabili e instabili, ma che qui è stato sfruttato al meglio con costruzioni adatte al caso. A guardarlo sembra quasi un miracolo, sospeso sulla vallata in cui scorre placido il torrente.
Parco del Grassano
San Salvatore Telesino, Campania
La Valle Telesina si trova nel cuore della provincia di Benevento, a pochi chilometri da Telese Terme, nota meta benessere sin dai tempi dell’antichità grazie alle sue acque sorgive messe a frutto da uno stabilimento termale. La natura è l’elemento che contraddistingue tutta la zona, tutelata in parte dal Parco del Grassano, oasi di vero relax disseminato di vestigia romane, castelli medievali e piccoli borghi dove è piacevole fare tappa fra un’escursione e un’attività sportiva proposta dall’ente parco. Canoa, rafting, MTB, trekking…o anche un semplice picnic nelle aree riservate: il Parco del Grassano è un vero punto di riferimento nel beneventano e non solo per chiunque sia in cerca di una meta per trascorrere una giornata all’insegna del benessere tout court.
Sagra della Castagna e del Tartufo Nero
Bagnoli Irpino, Campania
Il Tartufo Nero di Bagnoli Irpino PAT e la Castagna di Montella IGP sono due delle eccellenze più rappresentative del territorio dell’Irpinia e del Parco dei Monti Picentini, giustamente celebrate dall’annuale Sagra della Castagna e del Tartufo Nero che si svolge a Bagnoli Irpino nel periodo autunnale.
Tartufo e castagna, accompagnati da funghi e prodotti caseari, fra cui spicca il pecorino bagnolese a base di latte di pecore autoctone, fanno di questa Sagra un appuntamento fra i più attesi, popolato da circa un centinaio di stand distribuiti per le vie del borgo.
Spettacoli, concerti di musica popolare e danze folkloristiche completano il calendario, cui si aggiungono visite guidate ai siti di interesse nella zona. Un’occasione da non perdere per una full immersion in cultura, storia, arte ed enogastronomia dell’Irpinia.
Laceno d’Oro
Bagnoli Irpino, Campania
Bagnoli Irpino, 1959. Pier Paolo Pasolini e Camillo Marino fondano il primo festival dedicato al “cinema del reale” in Italia. Nasce l’evento che da lì a breve diventerà il Festival Internazionale del Film “Laceno d’Oro”, con un chiaro imprinting che mette al centro i problemi sociali, stimolando il dibattito e l’approfondimento, ma spesso rimanendo fuori dai circuiti della grande distribuzione.
Da allora, il festival prevede ogni anno a dicembre la proiezione di opere significative del cinema indipendente e di ricerca, oltre a una serie di iniziative collaterali in grado di attrarre un pubblico molto trasversale, per età e cultura.
Museo Civico e della Ceramica
Ariano Irpino, Campania
L’Irpinia e la ceramica. Una storia plurisecolare che affonda le radici nel passato, e che in ogni epoca ha visto compiersi evoluzioni, di stile, tecnica, gusto. A raccontare tutta questa ricchezza sono gli oltre 250 pezzi della collezione del Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, situato all’interno di Palazzo Forte.
Si va da ceramiche del IX secolo a maioliche dal Trecento in poi fino a opere contemporanee: in questo ampio excursus, brocche, piatti, fiasche e boccali dai colori solari illustrano gli usi, i costumi, le abitudini e i valori di un popolo e del suo territorio nell’arco di oltre dieci secoli.
Momento clou della ceramica arianese fu il Settecento, periodo in cui erano attestate ben 11 fornaci e circa 29 artigiani con diverse mansioni: faenzari, cretai, rovagnari e stovigliai, artefici di alcuni dei pezzi più notevoli conservati nel Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino. Fra questi, lucerne antropomorfe e zoomorfe, brocche e fiasche a segreto, estrose saliere, scaldamani a foggia di scarpetta, grandi piatti e piatti devozionali e così via.
Dove dormire
Scopri l’eccellenza italiana dell’Ospitalità. I migliori hotel, B&B, agriturismi, campeggi, country house e rifugi selezionati per te e certificati per la qualità dei servizi.
Scopri tuttiDove mangiare
Scopri l’autentica cucina del territorio e vivi un’esperienza unica nei ristoranti e negli agriturismi di eccellenza certificati Ospitalità Italiana.
Scopri tuttiFare esperienze
Vivi esperienze uniche e autentiche nelle produzioni aperte certificate Ospitalità Italiana
Scopri tutti